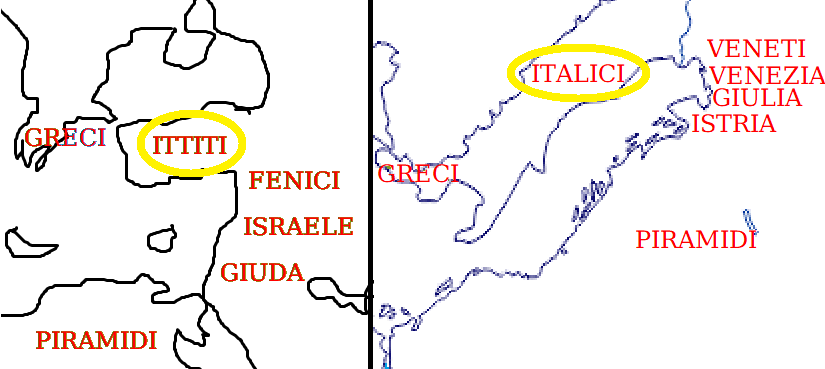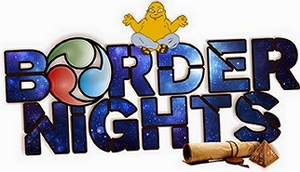- Messaggi: 308
- Ringraziamenti ricevuti 26
Nuova Cronologia
- orsoinpiedi
-

- Offline
- Utente bloccato
-

"la battaglia di canne per certi versi si rivelò strana, l'esercito di Annibale, molto inferiore di numero riuscì a CIRCONDARE quello romano e praticamente a sterminarlo. Un pò strano"
Vero,se prendi canne come campo di battaglia,dove l'esercito romano poteva schierarsi in tutta la sua ampiezza.76000 romani contro 40000/45000 cartaginesi.Ovvio che in ampiezza,considerando 16 le legioni romane(due erano a protezione dei due campi base),era impossibile per i cartaginesi accerchiare i romani.Allora è necessario trovare un altra zona adatta come campo di battaglia,dove il numero stesso dei romani impediva loro gli usuali movimenti in battaglia,lo scambio frequente ,nelle prime linee ,di truppe fresche.Ritengo che Annibale abbia cercato una piccola piana circondata da avvallamenti e collinette,trovandolo presso quello che oggi è il lago Occhito.
Mi scuso,ma lo scrivere sul cellulare non mi è facile.
"Leggi non per contraddire e confutare, né per credere e dare per scontato, ma per soppesare e considerare."
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Non avremo prove schiaccianti della loro esistenza, ma la letteratura greca riferisce ampiamente la loro leggenda, Omero per primo ne narrò le vicende dedicando loro un inno, riferito ai marinai in pericolo che li invocavano sacrificando a poppa degli agnelli bianchi, vedendoli così apparire all'istante: "lanciandosi dall'etere su pallide ali a sedare i turbini dell'uragano"... Alceo dedicò loro un altro inno: "corrono la Terra e i mari su rapidi cavalli e saltano da lontano girando luminosi sulle navi nelle notti avverse"... (qui c'è qualcuno che ci vedono dei dischi volanti). Riassumendo si può dire che erano invocati specialmente in momenti di estrema difficoltà, in mare e in battaglia. Arrivavano in soccorso velocemente e velocemente se ne dipartivano. Furono perciò per molti secoli ritenuti "divinità protettrici". I naviganti li associavano ai fuochi di Sant'Elmo, ovvero i fuochi di Castore e Polluce.
Un saluto
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- orsoinpiedi
-

- Offline
- Utente bloccato
-

- Messaggi: 308
- Ringraziamenti ricevuti 26
Per quanto concerne l'uso di esplosivi,o polvere nera,nella battaglia di Canne,lasciami dissentire.Non pensi che i Romani avrebbero fatto di tutto per capirne il segreto?Eppure i Romani non hanno mai avuto gli esplosivi.
Ricordiamo che la prima testimonianza scritta sulla composizione della polvere fu Qing Xuzi nel IX secolo d.C.
Curioso è il fatto di come inizialmente, da testi Taoisti,la prima formula della polvere da sparo fu ottenuta come sottoprodotto delle sperimentazioni cinese per la ricerca di medicinali.
Un fatto che ha cambiato il mondo.
"Leggi non per contraddire e confutare, né per credere e dare per scontato, ma per soppesare e considerare."
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- horselover
-

- Offline
- Utente
-

- Messaggi: 254
- Ringraziamenti ricevuti 14
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
horselover ha scritto: le divinità dell'antica grecia erano estremamente capricciose
Già già. Anche gli dei, si sa, sono delle voltagabbana... Probabilmente erano venuti a conoscenza che le vergini Vestali che accudivano il tempio a loro dedicato, non erano più tali... Da qui l'incazzatura...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
5.4. La tendenziosa distorsione dell’immagine dell’Atene medievale nei “lavori di restauro” del XIX-XX secolo
Volgiamo ora la nostra attenzione al momento in cui nel XIX secolo Gli Europei ottennero una dura e definitiva vittoria sugli Ottomani, e arrivarono sul territorio Greco in generale e in particolare ad Atene. Ci si potrebbe chiedere che cosa trovarono, per esempio, sull’Acropoli di Atene. Videro la cosa più ovvia del mondo. Praticamente Atene (incluso l’Acropoli) era piena di costruzioni Ottomane, torri e templi. Molte erano state danneggiate durante le guerre Ottomane del XVII-XVIII secolo. Per esempio, oggi ci viene raccontato che “quando scoppiò la guerra tra Venezia e l’impero Ottomano, una proiettile di cannone colpì il Partenone, dove i Turchi tenevano le loro munizioni. Queste esplosero, e molte delle sculture di Fidia furono distrutte” ([198], pag. 19). Comunque, non sono esclusivamente gli Ottomani a essere ritenuti responsabili per la maggior parte delle distruzioni che avvennero sul territorio della Grecia. Lord Elgin, per esempio e il pittore italiano Lusieri, che era a capo della Commissione Internazionale per il restauro di Atene molto si lamentarono pubblicamente poiché “lo stato delle statue sopravvissute era veramente deplorevole… ciò era dovuto alla guarnigione Turca dell’Acropoli; alcune delle statue erano state ridotte a pezzetti per la produzione di proiettili [? – A. F.]. Il Partenone rimase in gran parte in quelle condizioni persino dopo l’esplosione del 1687, e fu battezzato “l’antico tempio dell’idolo” dai Turchi, che periodicamente lo saccheggiarono in cerca di piombo” ([198], pag. 19). Questo significa che i saggi e generosi Europeo Occidentali erano fuori strada nel tentativo di preservare gli “antichi” capolavori Greci per la posterità – capolavori che, come di può capire, erano stati creati lì dagli Ottomani nel periodo “Mongolo” del XIV-XVI secolo. Fig. 7.36. Ritratto di Lord Elgin. Gli storici moderni dicono quanto segue dell’immagine: “La postura casual del giovane lord così sicuro di sé che si è permesso di rivendicare per sé i più grandi tesori della Grecia – in primo luogo, le sculture del Partenone e alcune altre costruzioni dell’Acropoli - e inviarle via nave in Inghilterra. Sua Eccellenza si ammalò gravemente un po’ di tempo dopo, e si coprì di piaghe (probabilmente risultato del trattamento della sifilide con l’utilizzo del mercurio e perse quasi completamente il naso. Appariva così malconcio che faceva davvero pietà” ([198], pag. 19). Le accuse moderne agli Ottomani per la totale distruzione della Grecia difficilmente possono essere interamente giustificate. Alcune delle distruzioni possono essere state naturalmente causate durante la conquista Ottomano = Ataman del XV-XVI secolo; comunque, gran parte venne distrutto durante la “guerra di liberazione” contro gli Ottomani nel XVII-XVIII secolo. Come sappiamo già, il famoso Partenone, per esempio, fu distrutto dai Veneziani, e non dagli Ottomani (vedi sopra e in [198], pagg. 15-16). Consideriamo ora la preservazione dell’antica eredità del passato nell’interpretazione degli Europei Occidentali civilizzati del XIX secolo. Dando un occhiata all’Acropoli, per esempio, hanno sostenuto con assoluta certezza che alcune delle costruzioni erano senza dubbio “Greche antiche” – e le altre orribili, barbariche Ottomane. Oggi non abbiamo alcuna conoscenza di come i nobili signori e i graziosi artisti separassero l’ “antichità” dal Medio Evo. Molto probabilmente, il loro ragionamento era piuttosto semplice. Ogni cosa che portasse segni visibili di Cristianità o Islam veniva considerato una distorsione della città di Atene classica. Torri, campanili, minareti, croci Cristiane, mezzelune Ottomane, iscrizioni Slave e Arabiche, sepolcri “irregolari”, ecc. erano chiaramente “imitazioni”. Ogni altra cosa veniva senz’altro dichiarata “antica”. Dopo la separazione tra costruzioni “incontaminate” da quelle “corrotte”, iniziò subito la seconda fase. Le costruzioni che potevano essere definite Greche d’autorità, senza prezzo, sarebbero naturalmente state preservate per la posterità e sarebbero servite come attrazione turistica per le genti del mondo. Per quanto riguarda le assurde e brutte costruzioni Ottomane – dovevano essere immediatamente rase al suolo per non rovinare la raffinata forma classica dell’antichità restaurata. Nel XIX secolo, un ondata delle nobili distruzioni fatte passare come “restauri” investì l’intera Acropoli. Tra l’altro, “Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, era tra i numerosi restauratori [di Atene – A. F.]... Egli finanziò la demolizione della torre di 21 metri costruita sul sito dei Propilei nel Medio Evo poiché pensò che la torre incrinasse l’armonioso contorno dell’intera Acropoli” ([198], pag. 99). Daremo un resoconto dettagliato della “vera” scoperta di Troia da parte di Schliemann, e racconteremo al lettore che cosa in realtà avesse disseppellito, in Chron2. E così successe che le costruzioni Ottomane, torri ed altre costruzioni furono distrutte su larga scala, con zelo, e con la consapevolezza di totale impunità, principalmente ad Atene. Alcune delle più rare fotografie che riflettono lo stato dell’Acropoli nel XIX secolo esistono ancora, e possono mostrarci lo stadio finale di questo “restauro scientifico”. In fig. 7.37 vediamo una panoramica fotografica dei dintorni del Partenone nel 1869. Il commento dato dagli storici è il seguente: “Nella fotografia panoramica fatta da Stillman nel 1869 possiamo vedere il Partenone nell’Acropoli con ancora una piccola parte delle abitazioni Turche che avevano coperto i resti antichi da cima a fondo, che vengono rimosse. Il restauro del tempio e la liquidazione metodica di strati di terreno non è ancora iniziata” ([198], pag. 34). Fig. 7.37. Una rara fotografia dei dintorni del Partenone datata al 1869. Viene riportato come questo territorio fosse stato già “parzialmente ripulito” dalla costruzioni Ottomane ([198], pag. 34). Comunque, si può ancora osservare l’ultima torre Ottomana a destra. Ripreso da [198], pagg. 34-35. Fig. 7.38. Un ingrandimento di una foto del 1869. Si vede in lontananza una torre medievale a destra del Partenone. Oggi non c’è più, poiché i restauratori Occidentali Europei sono stati abbastanza lungimiranti da cancellarla. Ripreso da [198], pag. 35. Come si può comprendere oggi, parecchio era già stato demolito e perciò non poteva più essere fotografato. Comunque, possiamo vedere un’alta torre Ottomana in questa vecchia foto, alla destra del Partenone. Oggi non esiste più. I restauratori l’hanno distrutta dopo il 1869 per mantenere il paesaggio classico con la sua armonia di linee, così almeno ci viene detto oggi. Le altre volgari fortificazioni Ottomane sono state distrutte, qv sotto. Un’altra fotografia di valore degli anni intorno al 1860 si può vedere nella fig. 7.39. Gli storici commentano come segue: “le fondamenta del piccolo tempio do Atena Nike (a destra in alto nella foto) vennero disseppellite solo nel 1835, quando fu distrutto il bastione Turco. La torre quadrata medievale dietro il tempio sarebbe stata demolita nel 1875, per ricostruire l’antica immagine di questa parte della città” ([198], pag. 38). Fig. 7.39. Una rara fotografia datata agli anni intorno al 1860. Questa parte della Acropoli deve le sue condizioni alla distruzione del bastione Ottomano = Ataman che un tempo stava lì ([198], pag. 38). Si vedono le fondamenta del tempio di Atena Nike e la torre medievale dietro di esso, la cui distruzione avvenne poco dopo. Non c’è traccia della torre Ottomana oggi. Ripreso da [198], pagg. 38-39. Fig. 7.40. Un ingrandimento di una vecchia foto degli anni 1860. È chiaramente visibile che la torre medievale Ottomana e le “antiche” fondamenta del tempio di Atena Nike hanno lo stesso tipo di muratura e sono costruiti con lo stesso tipo di pietra. Queste costruzioni ovviamente appartengono alla stessa epoca. Preso da [198], pag. 39. Comunque, l’ingrandimento di un frammento della fotografia che si può vedere in fig. 7.40 rende chiaro come la muratura della torre medievale sia identica a quella delle fondamenta dell’ “antico” tempio. Si ha l’idea che tutto questo sia stato costruito intorno allo stesso periodo dagli stessi costruttori con materiali da costruzione simili – intorno al XV-XVI secolo. E allora perché distruggere la torre Ottomana e lasciare intatte le fondamenta del vicino tempio? Si potrebbe pensare che andasse tirato giù allo stesso modo, essendo altrettanto medievale della torre. Evidentemente, l’unica ragione di ciò è la presenza di alcune colonne sulla fondazione medievale, che sono semplicemente state dichiarate “antiche” con un ipse dixit. Inoltre, la demolizione della torre Ottomana era una necessità assoluta poiché la vicinanza alle “antiche” fondamenta con identica muratura metteva in pericolo la storia Scaligeriana. Qualsiasi osservatore non affetto da pregiudizi avrebbe avuto il diritto di chiedere agli storici sulla differenza tra le costruzioni medievali e quelle antiche, e questi non avrebbero avuto nulla da rispondere. Dopo la distruzione di tutte le costruzioni che erano ovviamente medievali, di indizi Cristiani, o Ottomani, quelli rimanenti non avrebbero più potuto essere confrontati con nulla. Tutte le domande pericolose sarebbero divenute impossibili quando i detriti delle costruzioni e delle fortificazioni Ottomane fossero stati portati via. Le vecchie fotografie di queste parti non sono disponibili per molti. I restauratori Tedeschi, Francesi e Inglesi ([198]) erano perciò certi della loro impunità, e non avrebbero dovuto preoccuparsi delle domande di qualcuno che chiedesse le ragioni del fatto che costruzioni “antiche” e medievali fossero fatte degli stessi materiali e in maniera simile. Alcuni anni dopo le guide Ateniesi avrebbero rassicurato i turisti sul fatto che la “città era sempre stata così”. Non è difficile capire le guide, questo è quello che gli avevano detto gli storici. La scala dei “lavori di restauro” in Atene è stata realmente impressionante. Nelle figg. 7.41 e 7.42 si può vedere un’altra rara foto dell’anno 1865. Il commento degli storici è il seguente: “in questa foto dell’Acropoli fatta nel 1865 si possono osservare le irregolari escavazioni che vanno dalla cima al fondo dopo che le costruzioni Turche sono state tirate giù e portate via. I Propilei e la torre medievale che non sono stati ancora demoliti stanno sulla sinistra” ([198], pag. 40). In fig. 7.43 vediamo un ingrandimento del frammento fotografico che mostra la costruzione medievale Ottomana abbattuta poco dopo. Fig. 7.41. Una rara foto dell’Acropoli nel 1865. Si vede il risultato della demolizione di un gran numero di costruzioni Ottomane. Grandi pile di pietre e ghiaia scivolano lungo le pareti della fortezza. Si vede la torre medievale, ancora in piedi, sulla sinistra. Preso da [198], pagg. 40-41. Fig. 7.42. Un ingrandimento di una foto datata 1865. Vediamo i Propilei, e vicino una fortificazione Ottomana, insieme a cumuli di ghiaia delle costruzioni demolite dagli amorevoli restauratori. Preso da [198], pag. 40. Fig. 7.43. Un ingrandimento di una foto datata 1865. La torre medievale Ottomana chiaramente apparteneva allo stesso gruppo di costruzioni dei Propilei. Tuttavia non è sopravvissuta. Presa da [198], pag. 40. Abbiamo anche una foto dell’Acropoli Ateniese presa nel 1896 durante i Giochi Olimpici di Atene (vedi fig. 7.44). Si vede ancora la torre Ottomana, più alta del Partenone. Questo significa che c’erano diversi resti di costruzioni Ottomane nell’Acropoli verso la fine del XIX secolo, e anche piuttosto imponenti. Fig. 7.44. Un’immagine del 1896 con disegnata la successivamente demolita torre Ottomana sull’Acropoli. Era più alta del Partenone. Preso da [340], pag. 40. Fig. 7.45. Una vista dall’alto dell’Acropoli moderna. Si può chiaramente vedere che le “antiche” costruzioni lasciate intatte dai restauratori sono una minoranza dell’intero gruppo architettonico che occupava l’intera cima della rocca in epoca Ottomana. Evidentemente la maggioranza delle costruzioni era chiaramente troppo Cristiana e datata al XV-XVI secolo. È questo il motivo per cui è stata demolita in modo da “restaurare l’antico panorama”. Preso da [198], pagg. 100-101. In fig. 7.45 possiamo veder una moderna veduta a volo d’uccello dell’Acropoli. È chiaramente visibile che l’intera superficie della rocca era un tempo occupata da costruzioni di qualche tipo. Rimangono ancora solo i resti delle fondamenta. I “restauratori” del XIX secolo non hanno lasciato che poche costruzioni intatte – quelle che loro hanno deciso fossero “antiche” – cioè, il Partenone, i Propilei e alcune altre. Il resto, la parte chiaramente predominante delle costruzioni non li soddisfaceva – molto probabilmente per la loro indiscutibile origine medievale o Ottomana. é stata distrutte con nonchalance e portata via. I contorni del panorama sono così diventati armonici, secondo la franca e in qualche modo cinica affermazione fatta da Schliemann ([198], pag. 99). I resti delle fondamenta furono, con una certa preveggenza, lasciati intatti, poiché queste pietre silenziose non possono più dire alcunché a nessuno e anch’esse furono dichiarate immediatamente “davvero molto antiche”. I turisti rispettosi hanno cominciato a visitarle fin dalla fine del XIX secolo. Gli sarebbe stato detto che il grande Platone si sedeva e meditava “proprio su questa pietra”, e indicato dove il leggendario Demostene avrebbe indirizzato le sue ispirate orazioni stando su una pietra vicina. I turisti in posa avrebbero poi scattato innumerevoli fotografie. Il tendenzioso “restauro” di Atene continuò anche nel XX secolo. “L'Acropoli prese la sua forma moderna così famosa nel mondo dopo che l’ingegnere Greco Nikolaos Balanos incominciò a lavorare qui alla fine del XIX inizio del XX secolo ” ([198], pag. 99). Fece una gran mole di lavoro; comunque, sappiamo che la sua “ricostruzione” del Partenone, per esempio, aveva veramente poco a che vedere con l’immagine originale del tempio. “Grazie a Balanos, il Partenone riguadagnò la sua forma primigenia dal 1933, per quanto fosse possibile al tempo, e cominciò a sembrare nel modo in cui presumibilmente era 250 anni fa, sebbene le opinioni degli scienziati si polarizzarono sul fatto che questo risultato fosse lodevole. Già nel 1922, Anastasios Orlandos, assistente personale di Balanos, protestò contro la ricostruzione del colonnato… e cessò pubblicamente ogni collaborazione col suo superiore. Altri hanno accusato Balanos di voler costruire [e non ricostruire – A. F.] una prova grandiosa della gloria dell’Atene Pericleiana, senza curarsi troppo delle informazioni riguardo la forma del tempio. Quello che Balanos ha fatto veramente è stato utilizzare i primi pezzi di marmo trovati per la ricostruzione senza curarsi particolarmente della collocazione originale delle pietre. Inoltre, se la forma dei frammenti non lo soddisfaceva, Balanos li tagliava della forma che preferiva in modo che corrispondessero al piano generale” ([198], pag. 104). Come possiamo vedere, Balanos praticamente ricostruì i frammenti sopravvissuti del Partenone in un modo nuovo, guidato dal suo soggettivo concetto di “antichità”. Vi sono sufficienti prove della evidentemente tendenziosa ricostruzione dell’Acropoli da parte di Balanos, che aveva basato il suo lavoro sulla cronologia Scaligeriana. Per fare un esempio, pensò fosse una caricatura ricostruire le parti del Partenone che gli storici avevano considerato una moschea Mussulmana ([198]). Tutto appare chiaro. La cronologia Scaligeriana considera un crimine pensare che il Partenone fosse stato originariamente un tempio Cristiano, e fosse susseguentemente stato trasformato in moschea. Tutte le prove citate sopra che il Partenone fosse stato utilizzato come tempio Cristiano o Islamico vengono definite il risultato della sua “barbarica ricostruzione nel Medio Evo” dagli storici moderni. Comunque, oggi possiamo vedere dei cambiamenti in meglio. Un paio di anni fa, l’importante architetto Manolis Korres, che ha preso in carico il restauro del Partenone, ha dichiarato la sua idea di ricostruire la “moschea del Partenone”. Ovviamente ha trovato immediata e forte opposizione da parte degli storici. Si dice che “siano iniziati grandi dibattiti sull’idea di Korres di mantenere le tracce di alcuni dei cambiamenti fatti nel Partenone nei secoli. Per esempio, l’idea di rendere parzialmente visibile la moschea Mussulmana eretta all’interno del tempio” ([198], pag. 102). Per quanto ne sappiamo, i tentativi di Korres di far apparire il Partenone nel modo in cui era nel XIV-XVI secolo, almeno parzialmente, al momento non hanno portato a nulla. Concluderemo con un esempio minore ma molto istruttivo, che dimostra chiaramente come molti dei moderni “restauratori” vanno trattati con cautela. In fig. 7.46 possiamo vedere la famosa composizione che mostra Laocoonte che “fu trovata vicino a Roma durante il Rinascimento” ([198], pag. 12). Si suppone sia una copia in marmo del presunto I secolo D.C. fatta su un originale presumibilmente datato al II secolo A.C. tempi antidiluviani, insomma. Nonostante ciò, lo stile e la qualità della composizione ricorda molto, per esempio, i lavori di Michelangelo; cioè, assomiglia molto a lavori d’arte creati nell’epoca rinascimentale. Fig. 7.46. Una ricostruzione della statua del Laocoonte datata presumibilmente al XVI secolo. La mano destra di tutte e tre le statue è sollevata. Questo è molto probabilmente un originale fatto nel XVI secolo, e non una ricostruzione di qualche tipo. Preso da [198], pag. 13. Si ritiene che la composizione che mostra Laocoonte sia una ricostruzione del XVI secolo ([198], pag. 13). Comunque, è stata molto probabilmente realizzata semplicemente nel XVI secolo. Facciamo attenzione al fatto che le tre mani destre di tutte e tre le statue sono sollevate. Questo può avere qualche significato – religioso, per esempio. È difficile dire qualunque cosa di certo al giorno d’oggi. Comunque, il fatto più interessante riguarda ciò che osserviamo in fig 7.47, la quale mostra un’altra fotografia della stessa composizione che è già stata “restaurata” nel 1960 ([198], pag. 12). Fig. 7.47. Una “ricostruzione” del 1960 della statua di Laocoonte. I moderni restauratori hanno rotto tutte e tre le braccia alzate. La più grande ha solo qualche frammento invece del braccio che era stato d’autorità dichiarato “copia esatta dell’antico originale”. Preso da [198], pag. 12. Ciò che si vede è che i moderni restauratori hanno rotto il braccio destro di tutte e tre le statue per qualche ragione. Due di loro hanno adesso degli inutili moncherini. Come la statua centrale, la più grande, che ha un frammento curvo dopo lunghe considerazioni scientifiche. Gli storici affermano che questo fosse il frammento che cercavano tanto, rimasto seppellito nel sottosuolo per così tanti secoli. Si suppone sia stato trovato nelle “stanze dei depositi Vaticani” ([198], pag. 11). Gli storici moderni sono riusciti finalmente a riconoscerlo tra migliaia e migliaia di frammenti simili senza la minima ombra di dubbio, e l’hanno con sicurezza riconosciuto come il braccio destro perso di Laocoonte – molto più concordante del braccio che aveva posseduto per tre secoli, fin dal XVI secolo. Il braccio che non concordava è stato tagliato senza esitazione, come anche mezzo serpente, vedi figg. 7.46 e 7.47. I pezzi tagliati sono stati probabilmente buttati via come spazzatura inutile e al loro posto è stato messo il frammento congruo. Ovviamente, bisognava scrivere un articolo per dare basi scientifiche per questa assoluta necessità di miglioramento. Tuttavia, gli storici hanno involontariamente dimostrato che per far corrispondere il frammento ritrovato hanno dovuto danneggiare la vera statua di Laocoonte. Il commento recita: “il braccio disteso è stato sostituito dal frammento genuino appena ritrovato… c’è voluto un inserto di marmo per far combaciare i pezzi” ([198], pag. 13). Per quanto ci riguarda, è molto difficile riconoscere in questo una ricerca scientifica.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6. Strano paralleli nella storia delle religioni Scaligeriana
6.1. La Cristianità Medievale e il suo riflesso nell’ “antichità pagana” Scaligeriana
Diamo ora un breve resoconto della situazione per quanto riguarda la storia delle antiche Religioni. Oggi siamo convinti che ogni epoca possedesse suoi propri culti religiosi individuali, separati da centinaia e anche migliaia di anni. Gli storici ed etnografi del XIX secolo hanno fatto una grande quantità di studi comparativi riguardo a religioni globali e culti. È stato scoperto che certe religioni separate da secoli e anche millenni nella cronologia Scaligeriana hanno un gran numero di “parallelismi” tra di loro, o anche coincidenze, tanto più sorprendenti in quanto complete. Questo fatto indiscutibile ha prodotto un gran numero di teorie che ipotizzavano influenze, naturalizzazioni, infiltrazioni, ecc. Comunque, tutte queste speculazioni contemporanee sono basate solo sulla cronologia Scaligeriana. Un cambiamento cronologico porterà a una revisione del punto di vista prevalente sulla genesi e formazione delle religioni. Citeremo solo alcuni esempi tipici di parallelismi per spiegare l’effetto particolare delle “religioni duplicate” che osserviamo. Questo effetto è molto probabilmente figlio degli slittamenti Scaligeriani. Il cosiddetto “monumento Celtico” scoperto nel 1771 è oggi considerato essere l’effige di qualche dio dei boschi pagano Gallico pre-Cristiano ([966], Vol. 2, p. 465; vedi fig. 7.48). Comunque, ciò che vediamo sulla testa della divinità è una incisione che chiaramente dice ESUS. Che dovrebbe molto semplicemente stare per “Jesus.” Comunque, la pressione della cronologia Scaligeriana ha fatto affermare agli storici che questo fosse “un Gesù totalmente differente”. Solo un dio pre-Cristiano che aveva lo stesso nome, nulla più. Vedi anche [544], Volume 5, pag. 683. Fig. 7.48. Un monumento “Celtico” trovato sotto il solaio del coro di Notre Dame de Paris nel 1771 esposto oggi al Cluny Museum. Si può vedere la seminascosta e pur visibile iscrizione che dice ESUS, o Jesus. Comunque, gli archeologi considerano questa divinità un dio dei boschi pagano Gallico, pre-Cristiano e “molto antico”. Preso da [966], pag. 465. Arthur Drews, in importante specialista in storia comparativa delle religioni era solito affermare che praticamene tutte i presunti culti religiosi pre-Cristiani siano praticamente identici e paralleli (e , secondo la nostra ricostruzione, semplicemente rilessi tardi, ripercussioni, modificazioni) al culto Cristiano di Gesù Cristo ([259] e [260]). Scrisse che aveva “attribuito… grande significato ai paralleli mitologici tra la Cristianità e il paganesimo. Chiunque non veda le relazioni comunemente conosciute tra la storia della Resurrezione descritta nei Vangeli e i riti della religione di Atti-Adone-Osiride ecc., chiunque affermi che “non c’è nulla che assomigli minimamente” al seppellimento e alla resurrezione nei miti di Atti e Adone, chiunque cerchi di provare che la morte di Gesù sia stata diversa dal modo in cui i suoi cugini dell’Asia Minore erano morti… chiunque non riconosca Maria Maddalena e le altre Marie che vegliano intorno alla croce e alla tomba del Salvatore in quelle Indiane, Asiatiche ed Egiziane divinità madri chiamate Maia, Mariamme, Marithale… Marianne… Mandane, la madre di Ciro il “Messia”, la “Grande Madre” di Pessinunt, la Semiramide in lutto, Mariam, Merris, Myrrah, Myra (Mera) e Maya… dovrebbe ‘davvero tenersi lontano dai problemi della storia religiosa’ [per come la vede Weis].” ([259], pag. 150) A. Drews cita molti paralleli spettacolari che identificano la sacra famiglia di Gesù Cristo con altre “sacre famiglie” di dei Asiatici che si presume siano precedenti la nuova era di parecchi secoli. Se saltiamo fuori dalla cronologia Scaligeriana, vedremo che tutti questi paralleli indicano la simultaneità di questi culti, le cui differenze sono semplicemente la conseguenza delle caratteristiche etniche della loro localizzazione. Probabilmente tutte puntano alla medesima fonte comune – cioè sono un riflesso della vita e degli atti di Gesù Cristo nel XII secolo D.C. Gli storici del XIX-XX secolo, che hanno scoperto questi paralleli, sono rimasti legati alla cronologia sbagliata Scaligeriana, e hanno dovuto rovesciare il tutto. Come risultato hanno interpretato i paralleli come “tardo Cristiani” pescando pesantemente dai presunti “vari culti” e non producendo alcunché di originale o degno di attenzione. In fig. 7.49 possiamo vedere una foto del presunto Re Mesopotamico Assiro-Babilonese Ashur-Nazareh-Khabal, che si presume sia vissuto 930 anni prima della nascita di Cristo ([508], vedi anche [544], Volume 4, pag. 673). Comunque, quello che ha sul petto è semplicemente una croce Cristiana, molto simile a quella indossata oggi dagli eparchi Ortodossi. Questo è molto probabilmente un re medievale. Fig. 7.49. Il presunto re Mesopotamico Assiro-Babilonese Ashur-Nazareh-Khabal vissuto si presume nel 930 A.C. preso da [508]; vedi anche [544], Volume 4, pag. 673, ill. 139. Comunque, l’ “antico re Assiro” ha una croce Cristiana sul petto. Molto simile a quella indossata dai moderni eparchi ortodossi. In fig. 7.50 vediamo un antica immagine della “estremamente antica” divinità Fenicia Astarte ([508] e [544], Volume 4, pag. 673). Che ha uno scettro con una croce Cristiana nelle sue mani. É solo la cronologia Scaligeriana che impedisce agli esperti di storia delle religioni di identificare questa come un’effige medievale Cristiana Fig. 7.50. La presunta antica divinità Fenicia Astarte ([508] e [544], Volume 4, pag. 673, ill. 140). Ha uno scettro tra le mani con una croce Cristiana. In fig. 7.51 vediamo la presunta “antica” statuetta Gallica dell’ “antico” dio dei Franchi Giove. Comunque, il suo vestito è tutto coperto dalle consuete croci Cristiane ([508], [544], Volume 4, pag. 674). Fig. 7.51. Un presunta antica statuetta Gallica dell’ “antico” Dio dei Franchi Giove. Tutto il suo vestito è tuttavia coperto da croci Cristiane. Vedi [508] e [544], Volume 4, pag. 674, ill. 141. In fig. 7.52 vediamo un’ “antica” effige Egiziana della dea Isis che allatta al seno suo Figlio che ha una croce ansata Cristiana nella sua mano ([544], Volume 4, pag. 675). È difficile liberarsi dell'impressione che questa sia in realtà una rappresentazione medievale della Vergine Maria con suo figlio Gesù Cristo – con una datazione sbagliata per via della storia Scaligeriana e trasferita nell “antico” passato”. Fig. 7.52. L’ “antica” divinità Egiziana Isis che allatta al seno il figlio cil quale tiene una croce Cristiana nella mano. Preso da [544], Volume 4, pag. 675, ill. 143. In fig. 7.53 citiamo l’anagramma molto popolare nel medioevo del nome di Gesù Cristo nelle catacombe Romane ([544], Volume 4, pag. 675, ill. 144). L’anagramma 8 è chiaramente una croce ansata. Vediamo queste in grande abbondanza negli “antichi” disegni Egiziani e sculture, che vengono datate oggi come precedenti la nuova era di secoli e persino millenni. Croci ansate erano indossate come gioielli, come oggi, o tenute in mano. La croce Cristiana medievale era anche a volte interpretata some simbolo di una chiave. Fig. 7.53. Anagrammi medievali del nome di Gesù Cristo dalla catacombe Romane. Preso da [544], Volume 4, pag. 675, ill. 144. In fig. 7.54 segnaliamo una tabella estremamente interessante che mostra differenti forme delle croci Cristiane medievali ([1427], pag. 5). L’ “antica” croce ansata Egiziana è la numero 20. È da notare anche la croce a T (numero 3), e la croce biforcata (numero 5). Incontreremo ripetutamente queste piuttosto antiche versioni della croce Cristiana in futuro. Segnaliamo anche la numero 25, che è praticamente la mezzaluna Ottomana con una stella cruciforme. Fig. 7.54. Segnaliamo l’antica croce a forma di T (numero 3 nella tabella) come anche la croce biforcata (numero 5). L’ “antica” croce ansata Egiziana è la numero 20. Preso da [1427], pag. 5. Forme di croce: 1) Croce Greca; 2) Croce Latina (Alta croce); 3) Croce Tau, Croce di S. Antonio; 4) Croce di S. Pietro; 5) Croce biforcata; 6) Croce di S. Andrea (Decusse); 7) Croce Sprag;
 Croce Ripetuta, Croce Tedesca; 9) Croce a bracci; 10) Doppia croce, croce patriarcale, croce di Lotario; 11) Croce Ortodossa, o croce di Lazzaro; 12) Croce papale; 13) Croce a zampa; 14) Croce di bastoni; 15) Croce a trifoglio; 16) Croce a giglio; 17) Croce a diamante; 18) Croce circolare; 19) Croce ad aureola; 20) Croce a maniglia; 21) Croce Copta; 22) Croce a ruota, Ruota solare; 23) Croce Celtica; 24) Orbe; 25) Croce ad ancora; 26) Croce a gradini; 27) Croce di Gerusalemme; 28) Monogramma di Cristo; 29) Croce ad angolo, o croce a gamma; 30) Croce ad angolo; 31) Croce Rossa; 32) Croce di ferro; 33) Croce equilaterale; 34) Croce di Malta; 35) Svastica; 36) Croce uncinata. In fig. 7.55 vediamo la stampa di un “antico” sigillo Siriano presumibilmente datato al secondo millennio prima di Cristo ([533], Volume 1, pag. 457). Al suo centro si può chiaramente vedere la croce ansata Cristiana, il cui anello potrebbe essere stato utilizzato per indossarlo come pendente. Fig. 7.55. Una copia di un sigillo Siriano presumibilmente datato alla metà del secondo millennio prima di Cristo, Berlino, Museo del Medio Oriente. Preso da [533], Volume 1, pag. 457. Al centro del sigillo vediamo una croce ansata con un anello che facilita il suo uso come pendente. In fig 7.56 si vede una “antica” statuetta trovata a Hissarlyk, Asia Minore, che ritrae la divinità Maia ([544], Volume 4, pag. 676, ill. 145). Questa è molto probabilmente la Vergine Maria rappresentata come madre del futuro Gesù Cristo. La croce Cristiana è disegnata qui come svastica. Fig. 7.56. Un disegno medievale rappresentante evidentemente la Vergine Maria futura madre di Cristo considerata oggi un’effige dell’ “antica” divinità Maia. Preso da [544], Volume 4, p. 675, ill. 145. In fig. 7.57 vediamo un frammento di una statuetta di ottone dell’ “antico” Budda. Comunque, quello che vediamo sul suo petto è un gammadion Cristiano. Museo Russo di Etnografia e museo di Gimet in Francia ([544], Volume 4, pag. 677, ill. 146). Fig. 7.57. Una statuetta di ottone dell’ “antico” Budda con un gammadion Cristiano sul petto. Preso da [544], Volume 4, pag. 677, ill. 146. In fig. 7.58 c’è una sorprendente “antica” immagine del presunto “antico” Bellerofonte che combatte con una chimera ([508] e [544], Volume 4, pag. 687, ill. 150). Questo è semplicemente il medievale S. Giorgio che combatte il drago! Solo l’effetto ipnotico della cronologia Scaligeriana ha impedito agli amanti della “grande antichità” di riconoscerlo. Fig. 7.58 un’antica immagine del Classico Bellerofonte che combatte con un’ “antica” chimera. Questa immagine è virtualmente identica alle numerose rappresentazioni medievali di S. Giorgio che trafigge il dragone. Preso da [508] e [544], Volume 4, pag. 687, ill. 150. Molti dei presunti simboli Cristiani sono collegati alle cosiddette chiavi di S. Pietro che si suppone vengano utilizzate per aprire i Cancelli Perlati ([259]). Ricordiamo al lettore che la chiave è solo un’altra forma della croce ansata Cristiana medievale (vedi fig. 7.53, anagramma
Croce Ripetuta, Croce Tedesca; 9) Croce a bracci; 10) Doppia croce, croce patriarcale, croce di Lotario; 11) Croce Ortodossa, o croce di Lazzaro; 12) Croce papale; 13) Croce a zampa; 14) Croce di bastoni; 15) Croce a trifoglio; 16) Croce a giglio; 17) Croce a diamante; 18) Croce circolare; 19) Croce ad aureola; 20) Croce a maniglia; 21) Croce Copta; 22) Croce a ruota, Ruota solare; 23) Croce Celtica; 24) Orbe; 25) Croce ad ancora; 26) Croce a gradini; 27) Croce di Gerusalemme; 28) Monogramma di Cristo; 29) Croce ad angolo, o croce a gamma; 30) Croce ad angolo; 31) Croce Rossa; 32) Croce di ferro; 33) Croce equilaterale; 34) Croce di Malta; 35) Svastica; 36) Croce uncinata. In fig. 7.55 vediamo la stampa di un “antico” sigillo Siriano presumibilmente datato al secondo millennio prima di Cristo ([533], Volume 1, pag. 457). Al suo centro si può chiaramente vedere la croce ansata Cristiana, il cui anello potrebbe essere stato utilizzato per indossarlo come pendente. Fig. 7.55. Una copia di un sigillo Siriano presumibilmente datato alla metà del secondo millennio prima di Cristo, Berlino, Museo del Medio Oriente. Preso da [533], Volume 1, pag. 457. Al centro del sigillo vediamo una croce ansata con un anello che facilita il suo uso come pendente. In fig 7.56 si vede una “antica” statuetta trovata a Hissarlyk, Asia Minore, che ritrae la divinità Maia ([544], Volume 4, pag. 676, ill. 145). Questa è molto probabilmente la Vergine Maria rappresentata come madre del futuro Gesù Cristo. La croce Cristiana è disegnata qui come svastica. Fig. 7.56. Un disegno medievale rappresentante evidentemente la Vergine Maria futura madre di Cristo considerata oggi un’effige dell’ “antica” divinità Maia. Preso da [544], Volume 4, p. 675, ill. 145. In fig. 7.57 vediamo un frammento di una statuetta di ottone dell’ “antico” Budda. Comunque, quello che vediamo sul suo petto è un gammadion Cristiano. Museo Russo di Etnografia e museo di Gimet in Francia ([544], Volume 4, pag. 677, ill. 146). Fig. 7.57. Una statuetta di ottone dell’ “antico” Budda con un gammadion Cristiano sul petto. Preso da [544], Volume 4, pag. 677, ill. 146. In fig. 7.58 c’è una sorprendente “antica” immagine del presunto “antico” Bellerofonte che combatte con una chimera ([508] e [544], Volume 4, pag. 687, ill. 150). Questo è semplicemente il medievale S. Giorgio che combatte il drago! Solo l’effetto ipnotico della cronologia Scaligeriana ha impedito agli amanti della “grande antichità” di riconoscerlo. Fig. 7.58 un’antica immagine del Classico Bellerofonte che combatte con un’ “antica” chimera. Questa immagine è virtualmente identica alle numerose rappresentazioni medievali di S. Giorgio che trafigge il dragone. Preso da [508] e [544], Volume 4, pag. 687, ill. 150. Molti dei presunti simboli Cristiani sono collegati alle cosiddette chiavi di S. Pietro che si suppone vengano utilizzate per aprire i Cancelli Perlati ([259]). Ricordiamo al lettore che la chiave è solo un’altra forma della croce ansata Cristiana medievale (vedi fig. 7.53, anagramma  . Comunque, si scopre che la “antica mitologia classica” è anche piena di divinità il cui attributo primario è sia una chiave che una croce a forma di chiave – cioè, la croce ansata medievale. Così l’ “antico” Elios Greco, l’ “antico” Plutone Romano, l’ ”antico” Serapis Egiziano e l’ “antica” regina infernale Ecate ([259], pag. 58). Dupuis e Volnay segnalano l’identità di fatto dell’apostolo Pietro de dell' “antico” Dio Romano Giano. In fig. 7.59 vediamo le presunte “antiche” effigi di varie divinità “antiche” con bambini. Sono l’”antica” Giunone Romana con Marte (secondo Malver), l’indiana Devas con piccolo Krishnu (secondo Jeremias), Demetra con Bacco, o semplicemente “D-Mother,” o “Deo-Mater,” o Madre di Dio (Malver). E ancora vediamo l’ “antica” Diana con una croce sulla testa, e la mezzaluna Ottomana con una stella cruciforme vicino. Poi arriva l’ “antica” divinità Egiziana Athyr, o Hathor, col piccolo Osiride (Jeremias). Infine, vediamo la cosiddetta “Nostra Signora di Salisbury” (secondo M. Brocas). Vedi [544], Volume 3, pag. 631, ill. 101. Fig. 7.59. “Antiche” effigi di divinità con bambini; quello che vediamo sono probabilmente diverse rappresentazioni medievali della Vergine Maria con Cristo bambino. Preso da [544], Volume 3, pag. 631, ill. 101.
. Comunque, si scopre che la “antica mitologia classica” è anche piena di divinità il cui attributo primario è sia una chiave che una croce a forma di chiave – cioè, la croce ansata medievale. Così l’ “antico” Elios Greco, l’ “antico” Plutone Romano, l’ ”antico” Serapis Egiziano e l’ “antica” regina infernale Ecate ([259], pag. 58). Dupuis e Volnay segnalano l’identità di fatto dell’apostolo Pietro de dell' “antico” Dio Romano Giano. In fig. 7.59 vediamo le presunte “antiche” effigi di varie divinità “antiche” con bambini. Sono l’”antica” Giunone Romana con Marte (secondo Malver), l’indiana Devas con piccolo Krishnu (secondo Jeremias), Demetra con Bacco, o semplicemente “D-Mother,” o “Deo-Mater,” o Madre di Dio (Malver). E ancora vediamo l’ “antica” Diana con una croce sulla testa, e la mezzaluna Ottomana con una stella cruciforme vicino. Poi arriva l’ “antica” divinità Egiziana Athyr, o Hathor, col piccolo Osiride (Jeremias). Infine, vediamo la cosiddetta “Nostra Signora di Salisbury” (secondo M. Brocas). Vedi [544], Volume 3, pag. 631, ill. 101. Fig. 7.59. “Antiche” effigi di divinità con bambini; quello che vediamo sono probabilmente diverse rappresentazioni medievali della Vergine Maria con Cristo bambino. Preso da [544], Volume 3, pag. 631, ill. 101. Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- horselover
-

- Offline
- Utente
-

- Messaggi: 254
- Ringraziamenti ricevuti 14
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
ALESSANDRINISMO - Stile o maniera artificiale, dotta, raffinata, simile a quella considerata caratteristica della letteratura, specialmente della poesia, greca, che fiorì ad Alessandria sotto i Tolomei
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6.2. Cristianità Medievale e l’ “antico” Mitraismo
A. Drews fornisce un’illustrazione per [259] che rappresenta l’ “antico” dio Mitra in una cosiddetta “Icona Mitraica”, q.v. in fig. 7.60. La testa di Mitra ha un’aureola con raggi solari – esattamente come le aureole nelle icone di Cristo. L’aureola è ovviamente di origine Cristiana. Non riuscendo a comprendere l’errore profondo nella cronologia Scaligeriana, Drews fa il seguente cauto commento: “Difficilmente è una coincidenza che molte icone Cristiane ricordino questa effige. C’è un cerchio, o aureola, intorno alla testa della divinità.”
Fig. 7.60. “Antica” effige del dio Mitra. Vediamo un’aureola e raggi solari intorno alla testa, proprio come quelle che si osservano nelle icone medievali di Gesù Cristo. Preso da [533], Volume 2, pag. 154.
A questo commento replichiamo che non è Cristo che rassomiglia all’ “antico” Mitra, ma piuttosto che il Mitraismo era una forma del culto Cristiano dopo l’XI secolo D.C. Come sappiamo, la storia Scaligeriana considera Mitra un “antico” dio Ariano dall’Oriente, e susseguentemente un’ ”antica” divinità Persiana, il cui culto si era diffuso in tutta l’Asia Minore ([966], Volume 2, pag. 416). Una delle effigi dell’ “estremamente antico” Mitra si può vedere in fig. 7.61. Mitra viene mostrato qui mentre uccide un toro. È possibile che i combattimenti di tori, ancora popolari in Spagna e parte della Francia, sia il riflesso di questo soggetto archetipico – probabilmente anch’esso Mitraico, ma chiaramente di origine Cristiana, e riflesso in molte icone Ortodosse. Osserviamo l’icona della Trinità Ortodossa in fig. 7.63. Lo sfondo di questa icona è identico all’ “antico” basso rilievo che rappresenta Mitra che uccide il toro.
Fig. 7.61. Un effige dell’ “antico” dio Ariano e Persiano Mitra mentre uccide un toro. Preso da [966], Volume 2, pag. 416.
Fig. 7.62. L’icona Russa della “La Sacra Trinità” della prima metà del XVII secolo. Davanti vediamo l’ “antico” Mitra che uccide un toro, che rende questo soggetto Cristiano e Ortodosso (questo tema è spesso collegato oggi ad Abramo). Preso da [647], pag. 36.
Fig. 7.63. Un ingrandimento del frammento dell’icona della Santa Trinità Ortodossa con Mitra che uccide il toro. Preso da [647], p. 36.
A. Drews dice quanto segue sui forti ed estesi paralleli tra l’ “antico” Mitraismo e la Cristianità Medievale: “Il principale santuario Romano di Mitra era nel Vaticano, sul sito della Cattedrale di San Pietro. È lì che veniva adorato, insieme a Attis, che era riconosciuto ufficialmente persino prima… Mitra, o Attis, era chiamato Pater, Padre. Il Sommo Sacerdote di questa divinità era chiamato anch'esso “Padre”; il Papa Romano viene ancora chiamato Santo Padre. Quest’ultimo indossa una tiara, o mitra, sulla testa che è il copricapo di Mitra, o Attis… e le scarpe rosse (red soldier shoes - ? ndt) dei sacerdoti di Mitra, che tengono sia le chiavi del “Dio Pietra” [o San Pietro – A. F.], e hanno “il potere di obbligare e quello di permettere”… . Il Papa Cattolico equivale al Pater, il Papa del culto Mitraico. Questo Papa pagano risiedeva in Vaticano, adorava il sole come salvatore, e Cibele come la vergine Madre di Dio, normalmente rappresentata seduta con un bimbo in grembo – il suo doppio Cristiano è la Vergine Maria.” ([259], pag. 69) Come la Cristianità medievale, l’ “antico” Mitraismo aveva il concetto del purgatorio; i due riti avevano in comune anche l’uso dell’aspersorio, e il segno della croce ([259], pag. 70). Il cerimonialismo Ecclesiale e le forme dell’ufficio pubblico della chiesa sono simili – la liturgia veniva letta in una lingua morta che le masse non comprendevano, entrambi i servizi utilizzavano l’ostia (o altro pane), paramenti, cappelli episcopali, etc. Questo parallelismo venne scoperto dall’importante scienziato J. Robertson ([1371] e [259], pagg. 70-71). Scriveva che “Le divinità del salvatore orientali sono tutti fratelli di Gesù Cristo” ([1371] e [544], Volume 4, pag. 695). N. A. Koun ci dice anche che “l’offerta Mitraica è praticamente simile all’Eucaristia Cristiana… i Cristiani, come anche i Mitraisti, consideravano la Domenica un Giorno Sacro, e celebravano... il Natale nella tradizione Cristiana, il 25 Dicembre, come il giorno in cui la loro “invincibile” divinità era nata” ([454] e [544], Volume 4, pagg. 701-703). Alcuni monumenti che rappresentano una segreta Cena del Signore Mitraica hanno raggiunto i nostri giorni. Possiamo vedere pane da cerimonia con croci Cristiane in queste “antiche” rappresentazioni ([259], pag. 3). La famosa Cathedra Petri, o la Cattedra di San Pietro in Vaticano, sembrano anch’esse appartenere al culto Mitraico. Concludiamo che l’ “antico” culto di Mitra era praticamente identico al culto medievale di Gesù Cristo, e l’intervallo di diversi secoli che li separa è semplicemente un simulacro della cronologia Scaligeriana. “Il concetto di Mitra che arriva in Europa dall’Asia e non viceversa è basato sul fatto che troviamo un gruppo significativo di tracce di questo culto nei Veda, dove Mitra è una delle figure chiave” ([544], Volume 4, pag. 704). Questo implica che i famosi Veda, scoperti relativamente di recente, datino alla fine del Medio Evo e non a qualche ipotetica età antidiluviana. Il Mitraismo è presente anche nello Zoroastrismo, o religione di Zoroastro, che si presume sia stata quella prevalente nell’ “antica” Persia prima della sua conquista da parte di Alessandro il Grande. Si suppone che sia anche scomparsa improvvisamente per un periodo di sei secoli (!) per poi “rinascere” sotto i Sassanidi nel presunto IV secolo D.C. ([544], Volume 4, pagg. 715-716). Tutto questo porta alla conclusione che lo Zoroastrismo è anch'esso medievale nelle sue origini, datando al XI secolo D.C. al massimo. J. Frazer dice, sull’argomento dell’ “antico” Attis: “Attis… era stato lo stesso per la Frigia che Adone per la Siria… la tradizione e il culto delle due divinità era così simile che gli antichi spesso identificavano l’uno con l’altro” ([917], pag. 19). L’ “antica” religione Greca ha ancora echi dei vari attributi di Gesù Cristo. In particolare, esperti di storia delle religioni segnalano che “la figura del salvatore morente e risorto veniva incarnata da Dioniso e Bacco” ([743], pag. 41).
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
"Midrash (ebr. מדרש; plurale midrashim) è un metodo di esegesi biblica seguito dalla tradizione ebraica"
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6.3. Riferimenti a Gesù Cristo contenuti in “antichi” reperti Egiziani
L’antico Egitto viene considerato un “classico paese di passaggio”. La Mesopotamia, la Persia e l’India hanno tutte croci Cristiane simili. Come abbiamo già segnalato, molti “antichi” dei Egiziani sono rappresentati in disegni e bassorilievi mentre impugnano il glifo medievale di Cristo – una croce ansata ([259]). Così le divinità Re-Horakhty (fig. 7.64), Tefnut, la dea dell’umidità e della rugiada (fig. 7.65), e i leoni divini Shu e Tefnut (fig. 7.66). In fig. 7.67 possiamo vedere un’effige del dio Egizio Osiride che giace circondato da croci ansate Cristiane. L’ “antica” statua del faraone (fig. 7.68, sulla destra) è particolarmente impressionante. C’è un’estesa croce Cristiano Ortodossa sul retro del suo trono, vedi fig. 7.69. L’ “antica” statua è in mostra al Metropolitan museum di New York.
Fig. 7.64. Le “Antiche” divinità Egiziane Re-Horakhty e Hathor con croci Cristiane nelle loro mani. Preso da [486], pag. 119.
Fig. 7.65. L’ “antica” divinità Egiziana Tefnut con una croce ansata Cristiana in mano. Preso da [486], pag. 119.
Fig. 7.66. Le “Antiche” divinità leonine Shu e Tefnut con una croce ansata Cristiana tra di loro. Preso da [486], pag. 19.
Fig. 7.67. “Antica” effige Egiziana del dio Osiris che giace circondato da croci ansate Cristiane. Preso da [533], Volume 1, pag. 425.
Fig. 7.68. Scultura di “Antico” Faraone Egiziano in mostra al Metropolitan Museum di New York. Si può chiaramente vedere una larga croce Cristiano Ortodossa sul retro del trono del Faraone. Immagine scattata da A. T. Fomenko nel 1995.
Fig. 7.69. Un ingrandimento del retro del trono del Faraone. New York, Metropolitan Museum.
N. V. Rumyantsev a compilato una tabella che include 32 differenti versioni della Croce Cristiana. Queste croci erano in particolare numerose nell’intera “antica” regione Mediterranea, e vengono spesso datate a epoche ipotetiche A.C. L’evidente unità del simbolo è così sorprendente che solo questo, confermato da una gran mole di dati, basta a mettere in discussione la verosimiglianza delle datazioni Scaligeriane di tutti questi “antichi” culti. Si scopre che il culto di Iside era anche eccezionalmente simile al culto Cristiano medievale, poiché “venivano svolte messe al mattino, pomeriggio,e messe serali che erano estremamente simili a quelle Cattoliche e anche a volte a quelle della liturgia Ortodossa” ([259], pag. 71). L’esperto in storia delle religioni N. V. Rumyantsev non mette in dubbio la cronologia Scaligeriana che arbitrariamente sposta il culto di Iside, Osiride e Serapide in una distante era, ma nonostante ciò è costretto a osservare che “questa somiglianza tra la liturgia Egiziana e quella Cristiana è troppo grande e troppo sbalorditiva per essere una coincidenza” ([259], pag. 72). Segnaliamo anche che il nome del famoso dio Egiziano Osiride molto probabilmente origina da “Esu-Re,” o Gesù il Re. Così commenta N. V. Rumyantsev una delle “antiche” rappresentazioni Egiziane che si riferiscono chiaramente a eventi evangelici: “Questo è Osiride che risorge dai morti dopo essere stato sepolto per tre giorni. Viene ritratto nel momento della sua resurrezione, mentre esce dalla bara... Vicino a lui vediamo sua madre e sua sorella… Iside” ([743], pag. 10). Un’altra divinità Egiziana porge una croce al resuscitato Osiride. “La resurrezione di Osiride… avviene dopo il terzo giorno dalla sua morte. Questa festività dovrebbe finire con il “montaggio del palo di Osiride”. Il palo verrebbe elevato con l’aiuto di speciali macchinari… e montato verticalmente” ([743], pagg. 10-11). Questa “morte di Osiride al palo” è probabilmente un riflesso della crocifissione di Cristo. Ci occuperemo di questo in dettaglio più avanti. C’è una donna in piedi vicino a Osiride che risorge – proprio come la Cristiana Vergine Maria e Maria Maddalena che vengono spesso rappresentate con l’olio santo presso la bara di Cristo. In figg. 7.70, 7.71 e 7.72 vediamo cinque “antichi” bassorilievi Egiziani che ritraggono differenti momenti della nascita del Faraone Amenemope ([576] e [544], Volume 6). Questi si suppone sia avvenuta nel 1500 A.C., un millennio e mezzo prima della nascita di Cristo. N. V. Rumyantsev scrive: “Nella prima immagine vediamo un messaggero divino in piedi davanti alla regina vergine Met-em-ve [Maria? – A. F.] che dà l’Annunciazione della nascita di suo figlio [vedi fig. 7.70 – A. F.].
Fig. 7.70. Un’ “antica” immagine Egiziana che utilizza il soggetto evangelico della nascita di Cristo. L’Annunciazione. Preso da [576], pag. 81.
Fig. 7.71. Un’ “antica” immagine Egiziana che utilizza il soggetto evangelico della nascita di Cristo. L’Immacolata Concezione. Preso da [576], pag. 81.
Fig. 7.72. Un’ “antica” immagine Egiziana che utilizza il soggetto evangelico della nascita di Cristo. La nascita di Cristo e i Saggi dall’Est che portano doni.
Nella seconda immagine vediamo la spiegazione della discendenza del faraone: la sua Madre vergine e Amon il dio solare che si tengono in un abbraccio d’amore. La terza immagine elabora il significato della precedente e fornisce dettagli dell’Immacolata Concezione dal seme divino. Questa idea viene trasmessa attraverso la croce che viene tenuta vicino al naso di Met-em-ve [l’autore fa riferimento alla polisemia della parola Russa dukh, che significa sia “respiro” che “spirito” che “spettro”, ed esprime il pensiero che la croce simbolizzi l’immacolata concezione con la percezione olfattiva dello Spirito Santo], e la rotondità del suo ventre [vedi fig. 7.71 – A. F.]… i sacerdoti Egiziani potevano perciò scrivere le prime pagine della biografia del sovrano divino sulla parete del loro tempio.” ([743], pag. 130) Commentando questa sorprendente, ma non certo unica, serie di bassorilievi Cristiani ed Evangelici dell' “antico” Egitto, J. Robertson, l’importante esperto di storia delle religioni, scrisse che “l’analogia più esatta del mito Egiziano della nascita reale divina è quella con l’Annunciazione Cristiana” (citato in [743], pag. 130). Abbiamo appena analizzato tre dei cinque bassorilievi. Che dire degli altri due? “Tre di questi cinque soggetti raccontano vari momenti della sua nascita [di Amenemope], l’Annunciazione, il rapporto tra gli amanti… e il suo risultato – l’immacolata concezione… . Nella quarta illustrazione vediamo la reale nascita della divinità reale, e il quinto mostra l’adorazione del bimbo da parte dei Magi [esattamente nel modo rappresentato dal Vangelo, qv in fig. 7.72 – A. F.]. Le tre figure umane genuflesse [o i magi evangelici accompagnati da un re anch’esso in ginocchio, vedi Chron6 – A. F.] danno le benedizioni e portano doni [al piccolo Cristo? – A. F.] , e ci sono degli dei vicino a loro che fanno altrettanto… Consideriamo non necessari ulteriori precisazioni per queste immagini.” ([743], pag. 149) Gli storici segnalano che “essi (i soggetti evangelici dell’Annunciazione e dell’Immacolata Concezione – A. F.) hanno una grande somiglianza a simili soggetti pertinenti le biografie di altri famosi mitici salvatori del passato – per gli Ebrei… Sansone, il Babilonese e Fenicio Tammuz, o Adone, o l’Indiano… Buddha” ([743], pag. 132). Anche “la crismazione Egiziana, o il battesimo del faraone da parte dei re Horus e Thoth… che versano acqua benedetta sul re, rappresentato come una sequenza di croci qui… con lo stesso re che tiene un’altra croce nella sua mano” ([743], pag. 198). Una simile “antica” rappresentazione Egiziana si può vedere in Fig. 7.73.
Fig. 7.73. La magica resurrezione di un morto da parte degli “antichi” dei Egiziani. Il morto viene ritratto tra Anubi e un altro dio dal nome non definito. Preso da [486], pag. 66.
In fig. 7.74 vediamo rappresentazioni medievali Copte delle croci Cristiane ([544], Volume 6). Ricordiamo al lettore che i Copti erano i Cristiani Egiziani medievali. È chiaramente visibile come le croci ansate Copte medievali siano assolutamente identiche a quelle “antiche” Egiziane.
Fig. 7.74. Croci Copte medievali. Il disegno è nostro. Preso da [544], Volume 6, pagg. 1048-1049.
In fig. 7.75 si vede un “antico” obelisco Egiziano che è oggi collocato nella Roma Italiana, in Piazza Minerva ([1242], pag. 43). Vediamo una croce Cristiana sulla sua sommità. Oggi gli storici assicurano che questa croce è un aggiunta successiva. Siamo molto scettici su questo. Molto probabilmente gli obelischi, inclusi quelli Egiziani “antichi” , erano costruiti come alti piedistalli con lo specifico scopo di portare sulla cima croci o altri simboli Cristiani. Perciò furono realizzati nel XVI-XVI secolo .
Fig. 7.75. “Antico” obelisco Egiziano in Piazza Minerva a Roma. C’è una croce Cristiana sulla sua sommità. Preso da [1242], pag. 43.
Un simile obelisco Egiziano con croce Cristiana sulla sommità era stato eretto in Piazza San Pietro a Roma ([1242], pag. 43. vedi fig. 7.76). In fig. 7.77 vediamo un antica stampa che rappresenta lo stesso obelisco in Vaticano. Anche qui vediamo una croce Cristiana sulla guglia, qv in fig. 7.78. Comunque, un altra antica stampa datata al 1585 (fig. 7.79) si suppone riproduca lo stesso obelisco Vaticano, ma in modo completamente diverso, come posizione, sebbene si supponga sia disegnato come vicino alla cattedrale di San Pietro anche in questa immagine ([1374], pag. 121). La guglia di questo obelisco Egiziano in Vaticano è incoronato da una grossa sfera, probabilmente un’immagine solare (vedi fig. 7.79). Questo simbolismo è Cristiano poiché ci si riferiva a Gesù Cristo come al “Sole”.
Fig. 7.76. “Antico” obelisco Egiziano in Piazza San Pietro a Roma. Preso da [1242], pag. 42.
Fig. 7.77. Antica stampa rappresentante l’obelisco “Egiziano” in Vaticano con una croce Cristiana sulla guglia. Si presume che la stampa rappresenti una “nuova consacrazione” dell’obelisco. Preso da [1374], pag. 21.
Fig. 7.78. Ingrandimento di un frammento della stampa che rappresenta l’obelisco “Egiziano” con sulla cima la croce Cristiana. Preso da [1374], pag. 21.
Fig. 7.79. Un’immagine medievale rappresentante l’obelisco Vaticano di Piazza San Pietro in Roma che si presume datata al 1585. È diversa da quelle precedenti, poiché la sua guglia è coronata da un globo. Il globo dovrebbe simbolizzare il sole, uno dei simboli di Cristo. Preso da [1374], pag. 121.
È possibile che croci Cristiane o sfere solari siano state tolte da “antichi” obelischi Egiziani nel XVII-XVIII secolo, nella tumultuosa epoca della Riforma, per facilitare la datazione degli stessi a qualche ipotetico “antico” periodo molto prima di Cristo. Inoltre, c’è un obelisco del XVIII secolo di fronte alla facciata dell’ “antico” Pantheon Romano, che data al presunto II secolo D.C. (fig. 7.80). Comunque il suo stile non è diverso da quello degli altri “antichi” obelischi Egiziani che si vedono in altre piazze Romane o in Egitto. Tutti appartengono probabilmente alla stessa epoca e tradizione del XV-XVIII secolo.
Fig. 7.80. Un obelisco del XVIII secolo di fronte alla facciata dell’ “antico” Pantheon presumibilmente costruito nel II secolo D.C. Si può chiaramente vedere come l'obelisco del XVIII secolo rassomigli come stile agli altri “antichi” obelischi Egiziani. Evidentemente, la tradizione recente del XV-XVII secolo di costruire simili obelischi Cristiani esisteva ancora nel XVIII secolo. Preso da [726], pag. 61.
In fig. 7.81 vediamo un’immagine datata presumibilmente al 1650 che mostra un “antico” obelisco Egiziano coperto di geroglifici dacima al fondo. L’obelisco di Pamphilio si può vedere al centro con anche un alectrione o una colomba sulla cima (fig. 7.82). Entrambi sono ben noti simboli cristiani. Lo stesso “antico” simbolismo Egiziano dell’ alectrione si può vedere sulla cima di numerosi templi Cristiani dell’Europa Occidentale. In Chron6 dimostriamo che l’ alectrione viene utilizzato per simbolizzare la mezzaluna Ottomana=Ataman. Inoltre, moderni commentatori assicurano che Kircher, l’autore del libro del XVII secolo da cui proviene questa immagine, interpretava i geroglifici in una “maniera curiosa” ([1374], pag. 123). Sarebbe interessante scoprire cosa esattamente agli storici dei nostri giorni non piace della traduzione di Kircher. Non abbiamo ancora avuto occasione di studiare questo problema.
Fig. 7.81. Un’ “antica” stampa del 1650 che rappresenta “antichi” obelischi Egiziani coperti di geroglifici. L’obelisco di Pamphilio è al centro; si può chiaramente vedere un alectrione o una colomba sulla guglia – un simbolo Cristiano, in altre parole. Si possono ancora vedere simili immagini di volatili sulla cima di molte cattedrali medievali. Come dimostreremo in Chron6, erano solite simbolizzare la mezzaluna Ottomana. Preso da [1374], pag. 123.
Fig. 7.82. Un’immagine ravvicinata di un alectrione o una colomba sulla cima dell “antico” obelisco Egiziano di Pamphilio. L’immagine del volatile è un simbolo Cristiano. Preso da [1374], pag. 123.
In fig. 7.83 vediamo una stampa datata presumibilmente al 1499 che mostra un “antico” obelisco Egiziano montato su un elefante ([1374], pag. 119). Ancora una volta, osserviamo un simbolo solare sferico sulla cima dell’obelisco che rappresenta Gesù Cristo. Questa stampa è presa dal libro di Francesco Colonna che non smette di irritare i commentatori dei giorni nostri. Per esempio, riguardo a questo “antico” obelisco Egiziano dicono: “Questa romantica immagine pseudo-Egiziana era molto popolare nel XVI secolo. Il libro da cui [il disegno] è stato preso in origine viene chiamato Hypnerotomachia, ed è realmente un testo di romantica fantasia scritto in uno strano miscuglio di linguaggi – Italiano, Latino, un confuso Ebraico, e geroglifici di fantasia. Comunque, le illustrazioni sono molto ingegnose; lo stile ascetico veniva considerato realmente Classico da molti studiosi” ([1374], pag. 119).
Fig. 7.83. Un “antico” obelisco Egiziano sormontato da una sfera, la quale probabilmente simbolizza il sole – uno dei più comuni simboli di Gesù Cristo. La stampa presumibilmente data al 1499. Preso da [1374], pag. 119.
In altre parole, a dispetto del fatto che questo antico libro sia scritto in maniera piuttosto rigorosa, gli storici moderni conoscono la natura esatta delle “vere antichità Egiziane” meglio dell’autore medievale. La loro decisione consensuale è di trattare Francesco Colonna in modo paternalistico, cancellando abilmente questo libro dalla circolazione scientifica.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6.4. Studiosi di antiche religioni commentano le strane similitudini tra i culti dell’ “antichità” e quelli del Medio Evo
Le “antiche” leggende Greche raccontavano che l’ “antico” Dio Dioniso (fig. 7.84) aveva realizzato il miracolo di trasformare l’acqua in vino ([743], pag. 198). Esperti di storia delle religioni hanno notato che questo era perfettamente analogo al famoso miracolo evangelico della trasformazione dell’acqua in vino di Gesù Cristo a Cana in Galilea. Potrebbe la Galilea riferirsi alla “Gallia” o Francia e Cana alla ben nota città di Cannes? Saintyves scriveva che “dopo questo, nessuno può non vedere le origini del miracolo matrimoniale della Cana di Galilea… fin dal culto Dionisiaco e durante l’età del culto Cristiano, l’acqua non ha mai smesso di trasformarsi in vino il 9 gennaio” (citato in [743], pag. 259).
Fig. 7.84. Una presunta “antica” scultura dell’ “antico” dio Dioniso. La scultura è molto probabilmente medievale e data al XIV-XVI secolo. Tratto da [304], Volume 1, pag. 102.
Una gran mole di letteratura scientifica è dedicata ai paralleli tra le leggende dell’ “antico” Budda Indiano e Gesù Cristo. La biografia di Budda non solo include i principali miti evangelici, come l’immacolata concezione, il miracolo della nascita, la Candelora ecc, ma anche dettagli più precisi – il battesimo, la tentazione nel deserto e così via. Liste di simili paralleli possono essere viste nei lavori di Drews, Frazer, Saintyves, Rumyantsev, ecc. N. V. Rumyantsev scriveva quanto segue come riassunto della sua ricerca: “Un intera carovana di sofferenze, morte e resurrezione di antichi dei è passata di fronte ai nostri occhi; abbiamo visto la loro mitologia, studiato le loro feste e i loro riti. Comunque, a dispetto del fatto che abbiano nomi differenti, caratteristiche mitologiche individuali, diversi paesi di origine o specializzazioni, si sente chiaramente la presenza di qualcosa che li unisce tutti. Anche gli antichi avevano sottolineato questo fatto… . Infatti, se guardiamo gli ultimi secoli prima di Cristo e i primi secoli della nuova Era vediamo un quadro molto particolare. Tutte le divinità che abbiamo elencato con tutti i loro attributi sembrano miscelarsi tra loro, spesso fino a diventare indistinguibili. Osiride, Tammuz, Attis, Dioniso e un gruppo d’altri sembrano aver formato una qualche gestalt comune, trasformandosi in un una divinità sincretica che regna suprema sopra l’intero territorio dello stato Romano… le divinità si sono trasformate in una singola eclettica, ma di fatto unificata, figura di salvatore. Questa intensa fusione avvenne durante l’epoca dell’Impero Romano, e riguardò in particolare Roma stessa.” ([743], pagg. 44-45) Concludiamo con un dibattito su un altro problema per noi di grande interesse. N. A. Morozov dedicò una particolare attenzione ai frammenti evangelici dove “le nostre traduzioni parlano della crocifissione di Cristo. Io evidenzio “le nostre traduzioni” in particolare, poiché l'originale testo Greco dei Vangeli utilizza la parola stavros invece di “croce” e il verbo stavroo invece di ‘crocifissione”. Comunque, stavros si usa in riferimento a un palo e non a una croce” ([544], Volume 1, pag. 84). N. A. Morozov suggerisce la traduzione “esecuzione al palo” invece di crocifissione – cioè essere legato al palo. La trasformazione semantica della parola Greca per “palo” ( stavros) avvenne nella traduzione Latina della Bibbia dove, secondo Morozov: “La parola crux, o croce, fu utilizzata invece del Greco stavros, e il risultato di questa trasformazione ha influenzato l’interpretazione dell’originale parola Greca stavros. La traduzione Slava è effettivamente più precisa, poiché dice che Gesù fu “legato a un albero”… Cercando una possibile soluzione al mio dubbio, ho deciso di seguire il testo Slavonico Ecclesiastico e tradurre la parola Greca stavros come “palo”, e il verbo “stavroo” come “giustiziato al palo”, poiché non viene riportato alcun dettaglio dell’esecuzione.” ([544], Volume 1, pag. 85) In fig. 7.85 si vede un’antica miniatura tratta dalla Grande Cronaca Francese intitolata “Re Hildebert e Lotario assediano Saragozza e la Morte per lapidazione inflitta dai Franchi al Principe Romano Belisar [Belisario – A. F]” ([1485], pag. 156). Vediamo l’esecuzione di Belisario (il Grande Zar?). Fu legato a un palo e lapidato a morte (vedi fig. 7.86).
Fig. 7.85. Un’antica miniatura da un libro datato presumibilmente alla metà del XV secolo e intitolato Le Grandi Cronache di Francia. Rappresenta l’esecuzione del Principe Belisario [il nome ha qualche somiglianza con Velikiy Czar, che sta per “il Grande Zar” in Russo]. Legato a un palo e lapidato a morte. Tratto da [1485], ill. 186.
Fig. 7.86. Un ingrandimento della miniatura che rappresenta la lapidazione del Principe Belisario (il Grande Zar?). Tratto da [1485], ill. 186. Rivolgiamoci ora ai presunti “antichi” miti pagani Greci. Ercole è uno dei protagonisti dell’ “antica” mitologia Greca. Drews segnala come “Ercole che trasporta colonne era un simbolo molto sfruttato nell’antichità… Inoltre, il significato mistico riferito a quelle colonne è lo stesso della croce di Cristo. Possiamo vedere Dio piegato sotto… il peso delle colonne e riconoscerlo come il Salvatore del Nuovo Testamento” ([259], pag. 49). Perciò, l’immagine dell’ “antico” Ercole piegato sotto il peso delle colonne cruciformi è probabilmente un’immagine medievale di Cristo che porta la croce soffrendo sotto il gran peso. Vedi le immagini medievali di Tintoretto in fig 7.87, per esempio [1472], o quelle di Marco Palmezzano datato presumibilmente al XVI secolo, vedi fig. 7.88 ([713], ill. 129).
Fig. 7.87. Gesù Cristo che porta la sua croce sul Golgota. Dipinto di Tintoretto (XVI secolo )(frammento). Tratto da [1472], No. 27.
Fig. 7.88. Gesù Cristo con la croce. Dipinto del XVI secolo dell’artista Marco Palmezzano. Tratto da [713], ill. 129. A. Drews continua, dicendoci: “La croce con due braccia è nella Cristianità sia il simbolo della nuova vita che di tutte le cose divine… come entrambe le colonne dei culti praticati a Tiro o Libici relativi a Eracle, Shamash, o Simone… . Uno dei disegni ritrae Cristo che porta entrambe le colonne in modo da formare una croce inclinata.” ([259], pag. 49) L’ “antico” Ercole che porta una croce è presente nella storia Scaligeriana come un altro riflesso fantasma di Gesù Cristo. Ci stiamo riferendo al “medievale Imperatore Eraclio” che, scopriamo, viene spesso ritratto come portatore di croce, nello scenario nientemeno che di Gerusalemme. Il nome Eracle e Eraclio sono praticamente identici. Questo ci fa ricordare che Gesù era spesso chiamato Horus, da cui origina l’ “antico” nome egiziano Horus (vedi Chron6, Ch. 3). In fig. 7.89 vediamo un dipinto di Michael Wohlgemut creato nei presunti 1485- 1490. Il moderno commento è il seguente: “Il Re Eraclio a Gerusalemme… abbiamo una rappresentazione simultanea del re che si avvicina ai cancelli della città a cavallo… e poi scalzo che porta una croce” ([1425], pag.
 . Un ingrandimento in fig. 7.90. Il Re Eraclio viene anche dipinto scalzo mentre porta una croce in un’antica immagine che si può vedere in fig. 7.91.
. Un ingrandimento in fig. 7.90. Il Re Eraclio viene anche dipinto scalzo mentre porta una croce in un’antica immagine che si può vedere in fig. 7.91.Fig. 7.89 Il frammento di un dipinto di Michael Wolgemut nell’ala destra dell’ Altare di Caterina (1485-1490). Secondo gli storici, viene rappresentato il re Eraclio (o Eracle) ([1425], pag.
 . Si avvicina a Gerusalemme su un cavallo e poi viene rappresentato ai cancelli di Gerusalemme scalzo e con addosso solo una camicia mentre porta una grossa croce. Tratto da [1425], pag. 8.
. Si avvicina a Gerusalemme su un cavallo e poi viene rappresentato ai cancelli di Gerusalemme scalzo e con addosso solo una camicia mentre porta una grossa croce. Tratto da [1425], pag. 8.Fig. 7.90. Un ingrandimento che rappresenta il re Eraclio = Eracle che porta una grossa croce vicino alla città di Gerusalemme. Tratto da [1425], pag. 8.
Fig. 7.91. Un antica immagine del re Eraclio = Eracle che porta una croce vicino a Gerusalemme. “Il Re Eraclio scalzo ai cancelli della città”. Tratto da [1427], pag. 103. vedi anche [1425], pag. 9.
Il crocifisso che si vede nella Cattedrale di Colonia viene chiamato “Il crocifisso di Gero,” vedi Chron6, Capitolo 3. Segnaliamo che la “Tomba di Cristo” che si trova sul Monte Beykos vicino a Istanbul è anche chiamata “Tomba” o “Luogo di riposo di Eracle” ([240], pagg. 76-77). Dettagli su Chron6. Molto probabilmente l’ “antico” Eracle, come anche il re medievale Eraclio, sono duplicati fantasma del Cristo = Horus del XI secolo. Entrambe le antiche immagini del re Eraclio lo mostrano mentre porta una croce a forma di T, che dev’essere la forma originale della croce Cristiana. In fig. 7.92 vediamo un’antica scultura da Palmira, la cosiddetta “Triade Divina di Palmira” che si presume databile al 150 A.C. ([1237]). I personaggi che osserviamo, comunque, sono chiaramente santi Cristiani. Due di loro hanno aureole Cristiane sulle loro teste. Inoltre, il santo sulla sinistra ha una mezzaluna Ottomana dietro la sua testa. Bisognerebbe sottolineare il fatto che il braccio destro di ogni statua è stato spezzato, ma il resto della scultura è in buone condizioni. È possibile che le mani destre fossero sollevate nel segno della benedizione Cristiana? È possibile che qualche devoto Scaligeriano abbia distrutto le loro dita sollevate nel familiare gesto Cristiano per eliminare questa evidente reliquia medievale dall’ “antichità”.
Fig. 7.92. Un’ “antica” scultura a Palmira, la cosiddetta “Triade Divina di Palmira” datata presumibilmente al 150 A.C. È molto probabile che rappresenti in realtà santi Cristiani con aureola. Uno di loro ha una mezzaluna Ottomana sulla testa. Tratto da [1237].
Questa sequenza di fatti prova che la Cristianità e l’ “antico” simbolismo condividono la stessa origine Medievale che può essere tracciato fino al XI-XIII secolo D.C. In fig. 7.93 vediamo un ritrovamento archeologico dall’Iran datato presumibilmente al XIII- XII secolo A.C. ([1237]). Si trova al momento al Louvre e viene considerata un’ “antica” immagine di qualche “mostro di fantasia”. Comunque, un osservatore non prevenuto riconoscerà immediatamente l’aquila bicefala, un ben noto simbolo imperiale nel Medio Evo.
Fig. 7.93. Un’ “antica” effige trovata in Iran e datata presumibilmente al XIII-XII secolo A.C. Ci viene detto che sia l’effige di qualche “mostro preistorico di fantasia”. È tuttavia difficile non riconoscere il ben noto simbolo medievale imperiale dell’aquila bicefala. Tratto da [1237].
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
In questi giorni, non ricordo il motivo di partenza, ho recuperato dalla libreria il suo classico "Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza" e dopo la lettura di Fomenko mi ha molto impressionato la quantità di dati che potrebbero tornare utili a chiarire ulteriormente il problema della cronologia e in particolare del "prima" della scrittura.
Jaynes non mette in dubbio la cronologia Scaligeriana. Era uno psicologo e vedeva nella Bibbia, nell'Iliade e nell'Odissea un tipo di pensiero "bicamerale". In soldoni, i personaggi di questi libri non riflettono su sé stessi, non hanno quella che noi chiamiamo coscienza del sé ma rispondono semplicemente ai comandi e agli stimoli degli dei. Questi comandi arriverebbero dall'area di Wernicke nell'emisfero destro (il contrario per i mancini), quell'area del cervello che viene più o meno considerata un inutile doppione della sua parte speculare sinistra. Mi fermo qui per non farla troppo lunga, si trova qualcosa in rete di più preciso.
Se l'ipotesi di Fomenko è corretta e la storia scritta dell'umanità inizia intorno all'anno mille potrebbe essere che nel periodo precedente la società umana fosse organizzata con questa mente bicamerale in cui voci che venivano identificate come quelle degli dei dicevano in modo autoritario agli uomini cosa fare. Jaynes fa anche esempi in cui l'attività dell'uomo è impegnata in complesse operazioni senza che vi sia una coscienza attiva di quello che si sta facendo (per es guidare un'auto ecc) e quindi non esclude la formazione di società complesse per questo insieme di "comandi divini" che potevano essere la somma delle esperienze di quella società. Mi fermo qui. Sto rileggendo il testo. Eventualmente ne accennerò ancora. Già che vi sono aggiungo il carico da novanta, Jaynes mi perdoni. Le società complesse come quelle delle termiti o delle api compiono azioni che sono inspiegabili se non facendo intervenire il generico "istinto". Anche loro potrebbero ricevere stimoli di un tipo analogo alle "voci degli dei".
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
via...
aggredire una donna...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6.5. Mosé, Aronne e la loro sorella, la Vergine Maria nelle pagine del Corano
Come appare dalla suddivisone del “Manuale di storia Scaligeriana” in una somma di quattro cronache più brevi, abbiamo diverse opzioni per datare l’era dell’Egira Mussulmana, che oggi viene datata al 622 D.C. Tutte sostituiscono la versione Scaligeriana. N. A. Morozov cita un gran numero di eccezionali stranezze per quanto riguarda la storia Mussulmana come per quella Cristiana. Facciamo un esempio. La cronologia del Corano è spesso radicalmente diversa dalla cronologia Scaligeriana della Bibbia. Il Corano sostiene che Aronne (Ario?) sia stato nientemeno che lo zio del Gesù evangelico. Maria, la madre di Gesù, viene dichiarata sorella di Mosé e Aronne. Perciò, secondo il Corano, questi personaggi del Vecchio Testamento appartengono alla generazione che è immediatamente precedente a Gesù Cristo. Naturalmente, questo è in contraddizione evidente con la cronologia Scaligeriana, essendovi una discrepanza di diversi secoli. Però, corrisponde bene con la nostra cronologia abbreviata. Rivolgiamoci alla 19a sura del Corano ([427], pag. 239). Il commentatore del Corano I. B. Krachkovsky scrive che questa è la più antica Sura che cita simili personaggi evangelici come… Maria e Gesù...” ([427], pag. 560). La 19a Sura si riferisce alla nascita di Gesù, figlio di Maria, nella seguente maniera: “O Maria, tu che hai compiuto opere di cui non si era mai sentito parlare! O sorella di Harun [Aronne – A. F.]…” ([427], la 19th Sura, 28(7); 29(28), pagg. 240-241). Il commento a questo frammento è il seguente: “la sorella di Mosé e Aronne è la madre di Gesù” ([427], pag. 561, No. 17).
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
6.6. Il XII secolo evidente periodo della vita di San Marco. La storia della Cattedrale di San Marco a Venezia
La gigantesca cattedrale Veneziana di San Marco è realmente una gemma architettonica che adorna la città. È anche una delle più popolari costruzioni medievali in Italia. La sua storia diventa particolarmente affascinante per illuminare la nuova cronologia abbreviata. Incominciamo ricordando al lettore la storia ufficiale di San Marco come viene riportata nei libri intitolati Basilica di San Marco ([1265]) e Venezia ([1467]). Questo è ciò che apprendiamo [1265]:“La Basilica di San Marco è oggetto di adorazione da parte dei Veneziani poiché simboleggia la loro storica unità. È senza dubbio il principale simbolo di Venezia e attrae i visitatori da ogni dove per l’unicità delle sue bellezze e il suo splendore orientale. La Basilica di San Marco è stata una cappella ducale fino alla fine del XVIII secolo e ha perciò assorbito la storia secolare ed ecclesiastica della repubblica Veneziana. Dal 1807, quando la chiesa fu trasformata nella cattedrale della città sostituendo la chiesa di San Pietro di Castello in questo ruolo, divenne la Mecca non solo per i Veneziani, ma anche per i visitatori nel mondo. Il suo vescovo porta l’antico titolo di Patriarca. La costruzione iniziale della Chiesa di San Marco avvenne... dopo l’828 D.C., quando il corpo di San Marco venne salvato dalla profanazione e spedito da Alessandria su una nave da alcuni Veneziani”. ([1265], pag. 7). La storia si sviluppa in questo modo: oggi San Marco si suppone sia stato il primo dei quattro evangelisti canonici ([765]). Il suo Vangelo – Il Vangelo secondo Marco – si presume sia il più antico, scritto intorno al 50 D.C. per l’insistenza sia di San Pietro che della comunità Cristiana. Tempo dopo Marco ritornò ad Alessandria, in Egitto, dove morì il 25 aprile nel presunto anno 68 D.C. ([1265], pag. 26). La cronologia Scaligeriana contiene un vuoto di informazioni di molti secoli per quanto riguarda San Marco, il cui nome si suppone ricompaia dall’oblio nel IX secolo D.C. – un millennio più tardi, in altre parole. Il suo corpo si suppone sia stato segretamente spedito nella Venezia Italiana da Alessandria in Egitto. La leggenda canonica è la seguente ([1265]): due commercianti Veneziani fecero una visita a una chiesa Cristiana di Alessandra consacrata a San Marco che ospitava il suo ossario. Qualche monaco, e anche il priore, si lamentarono con loro per le continue profanazioni inflitte alla chiesa dai Mussulmani che cercavano di convertire tutte le chiese Cristiane in moschee. I commercianti Veneziani estrassero il corpo di San Marco e lo contrabbandarono fuori da Alessandria in un cesto con ortaggi e carne di maiale. Dopo in viaggio per mare pieno di gravi pericoli, la reliquia salvata arrivò a Venezia, dove iniziò immediatamente la costruzione di un nuovo tempio come santuario per San Marco. Tutti gli episodi di questo rapimento vengono illustrati con intarsi che coprono le pareti della cattedrale Veneziana. La prima chiesa di San Marco venne quindi costruita dopo il presunto anno 828 D.C. come santuario per il suo corpo “miracolosamente salvato” da Alessandria. Comunque, purtroppo, non ci sono tracce della prima chiesa di San Marco da nessuna parte. Gli storici dicono: “C’è un gran numero di ipotesi differenti concernenti la forma di questa chiesa originale, tutte basate su un numero molto esiguo di ritrovamenti archeologici” ([1265], pag. 7). La prima Basilica di San Marco si suppone sia bruciata nel presunto anno 976. Secondo [1265], pag. 7, “fu immediatamente ricostruita.” Come risultato la seconda Basilica di San Marco fu costruita a Venezia, si suppone alla fine del X secolo. Anch’essa fu distrutta ([1265]). Perciò, intorno al presunto 1063, il doge Domenico Contarini iniziò la costruzione di una nuova chiesa più grande sul sito della seconda basilica. Si presume che questa terza basilica fosse costruita al modo della Basilica dei Dodici Apostoli di Costantinopoli. Qui incominciano le stranezza, coperte dal mistero. Vedete voi, citiamo letteralmente: “La riscoperta [sic! – A. F.] del corpo di San Marco è l’ultimo episodio della leggenda Veneziana. Durante la ricostruzione della terza basilica, l’ossario fu nascosto così bene [?! – A. F.] che parecchi anni dopo, dopo la morte del doge, nessuno aveva idea sulla sua possibile localizzazione. Fu solo nel 1094, dopo parecchi giorni di preghiere appassionate del doge Vitali Falier, il Patriarca, e l’intera popolazione, che la sacra reliquia [il corpo di San Marco – A. F.] si manifestò da sé miracolosamente da dentro una colonna [sic! – A. F.]”. ([1265], pag. 67). Questo evento miracoloso viene anche rappresentato negli intarsi della Cattedrale di San Marco. Sotto si può vedere il famoso dipinto che lo descrive opera dell’artista del XVI secolo, Tintoretto. Allora, ci stanno dicendo chiaramente in un modo insensato che i Veneziani del XI secolo erigevano la gigantesca cattedrale di San Marco senza avere la più pallida idea del posto in cui si trovava la sacra reliquia che era la ragione principale per la costruzione della cattedrale. E per tutto il tempo, il corpo di San Marco l’evangelista era proprio lì, sul luogo della costruzione! Evidentemente la cattedrale venne eretta prima; dopo di ciò la perdita della sacra reliquia venne improvvisamente notata e la sua ricerca fu lunga e infruttuosa. Ci vollero le preghiere ferventi del doge, del Patriarca e dell’intera popolazione di Venezia per far si che il corpo dell’evangelista si manifestasse dentro una colonna di pietra (?). Tirato fuori con la massima cautela (significa che la colonna in pietra venne distrutta?) e solennemente seppellito vicino all’altare. È lì che giace, fono ad oggi, il corpo di San Marco, oggetto centrale dell’adorazione nella cattedrale. La cronologia Scaligeriana di questo evento da noi riportato viene mostrata in fig. 7.94. È notevole che l’importante artista del XVI secolo Tintoretto avesse un’idea del tutto diversa della storia del seppellimento di San Marco nella cattedrale. Il suo famoso dipinto su questo soggetto si può vedere in fig. 7.95 ([1472]). Da sottolineare che San Marco non ricorda una mummia disseccata neanche un po’, assomigliando a un uomo appena morto e che sta per essere seppellito, q.v. nel lato sinistro del dipinto. Secondo l’opinione prevalente nel XVI secolo, San Marco evangelista fu seppellito nella cattedrale costruita specificatamente per questo scopo nel presunto XI secolo in modo appropriato per una persona che era appena morta e richiedeva grandi onori. Come si può vedere, non c’è stato nessun “vagabondaggio millenario del corpo di San Marco” nella percezione del Tintoretto.
Fig. 7.94. La cronologia Scaligeriana degli eventi in relazione al seppellimento dell’evangelista Marco a Venezia.
Fig. 7.95. Un dipinto del XVI secolo di Tintoretto intitolato “La scoperta del corpo di San Marco”. Potrebbe aver avuto un altro titolo in un certo periodo tipo “Il seppellimento di San Marco”. Tratto da [1472], ill. 17.
Evidentemente, la bizzarra leggenda del “pellegrinaggio del corpo di Marco” è stato il prodotto di sforzi degli storici più tardi per indagare in profondità gli eventi reali del XII secolo e farli coincidere con l’erronea cronologia Scaligeriana. Questo è ciò che pensiamo sia realmente accaduto. Marco, il primo evangelista, visse nel XII secolo D.C. e morì nella seconda metà di quel secolo. Fu seppellito per la prima e ultima volta nella Cattedrale di San Marco, eretta in suo onore. Questa opulenta inumazione, che ebbe luogo nel presunto anno 1094 (più probabilmente intorno al 1194) col doge, il patriarca, e l’intera città presente, fu più tardi erroneamente interpretato come la riscoperta del suo corpo, poiché la cronologia Scaligeriana aveva già fatto slittare il periodo della vita di San Marco nel I secolo D.C. Non c’è stata ne’ una scomparsa misteriosa ne’ miracolose riscoperte. Queste leggende datano a un età più tarda, quando gli storici cercarono di far coincidere la cronologia Scaligeriana con i documenti che esplicitamente indicano il XII secolo come periodo della vita e dell’attività di San Marco. La cattedrale di San Marco ovviamente assunse la forma attuale parecchio tempo dopo il XII secolo. Quando guardiamo questa cattedrale oggi vediamo una costruzione finta nel XVI secolo. Sulle sue pareti vediamo intarsi che illustrano la leggenda piuttosto fantasiosa del destino della città. Persino entro il paradigma cronologico Scaligeriano, la costruzione della cattedrale continuò anche nel XIII secolo, quando venne adornata con un gruppo scultoreo equino presumibilmente portato via dall’ippodromo di Costantinopoli di Bisanzio ([1467], pag. 39). È difficile definire con precisione l’esatto luogo in cui risiedette San Marco. Avrebbe potuto essere l’Asia Minore o Costantinopoli, come sostiene la storia Scaligeriana, e non l’Italia. Ma, ad ogni modo, il periodo della sua vita cade all’interno del XII secolo D.C. e non prima. L’idea che San Marco abbia potuto vivere a Venezia per qualche tempo è indirettamente sostenuta dal fatto che “per molti secoli la città venne associata col simbolo del leone alato che la tradizione Cristiana ascrive a San Marco evangelista. Le bandiere Veneziane, le chiese, palazzi e navi, come anche le terre conquistate dai Veneziani portano tutte il sigillo del leone alato” ([1265], pag. 27). È comunque possibile che l’Italia ricevesse i “diritti d’autore” per San Marco semplicemente come risultato di un transfer cronologico e geografico di eventi Bizantini di Costantinopoli (sulla carta, naturalmente). Questa conclusione si adatta alla nostra ipotesi che Gesù Cristo sia vissuto nel XII secolo D.C.. Marco, l’evangelista, è vissuto nello stesso secolo es è morto alla fine dello stesso. L’implicazione è che gli altri tre evangelisti – Luca, Matteo e Giovanni – non possono aver vissuto prima del XII secolo, poiché hanno scritto i vangeli dopo Marco, secondo la storia Scaligeriana. Sarebbe davvero molto interessante anche trovare le vere tombe dei tre evangelisti.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
7. L’ “antico” Egitto e il Medio Evo
7.1. Il bizzarro grafico delle datazioni nei testi in demotico
Abbiamo dato un dettagliato resoconto della storia Egiziana in Chron5. Attualmente ci limiteremo a diverse brevi annotazioni introduttive. Come già riportato in Chron1, Capitolo 1, la cronologia Scaligeriana dell’Egitto contiene vuoti giganteschi e, in realtà, consiste di frammenti assortiti, collegati tra loro in una maniera arbitraria o del tutto indipendenti. [1069] Contiene una lista completa di tutti i testi demotici datati nel 1966. Va da sé che certi testi Egiziani non possono essere datati esattamente. Ci asterremo dal considerarli qui e ci orienteremo invece su quelli descritti in [1069]. È estremamente istruttivo osservare la loro distribuzione sull’asse della storia Scaligeriana. Il risultato può essere visto in fig. 7.96. Il risultante grafico è veramente degno di nota.
Fig. 7.96. Distribuzione della quantità per documenti Egiziani in demotico compilata utilizzando i dati tratti da [1069]. L’attenzione si rivolge immediatamente verso strani intervalli all’inizio e alla fine del Secondo Impero Romano, come anche a una mancanza sospetta di simili documenti relativamente all’epoca del Terzo Impero Romano.
Per prima cosa, si vede che la maggior parte dei testi Egiziani in demotico cade nell’epoca del Secondo Impero Romano presumibilmente coprendo il periodo del I-III secolo D.C. È significativo che gli intervalli nel grafico corrispondano alla struttura del Secondo Impero Romano. Alcuni di loro sono datati a epoche precedenti, ma sono separati dal Secondo Impero Romano da uno strano vuoto a metà del presunto I secolo D.C. Secondariamente, il grafico in fig. 7.96 mostra l’assenza completa di documenti demotici datati nell’epoca del Terzo Impero Romano. La cronologia Scaligeriana dei testi demotici si rivela perciò una raccolta di diversi documenti in cui le relazioni sono piuttosto improbabili e fantasiose. Questi gruppi sono separati da vuoti i cui confini coincidono in modo particolare con i punti di rottura tra i duplicati dinastici che abbiamo scoperto con l’aiuto di metodi completamente diversi – basati sull’analisi statistica, qv in Chron1, Capitolo 5. Dunque, lo schema cronologico risulta essere una corrispondente riduzione dell’ “antica” cronologia Egiziana.
7.2. Gli enigmatici “periodi di revival” nella storia dell’ “antico “ Egitto
In Chron1, Capitolo 1, abbiamo già descritto come la cronologia Egiziana sia la più giovane tra le discipline storiche. La sua formazione è basata sulla esistente cronologia Scaligeriana di Roma e della Grecia, e dipende perciò da essa fin dall’inizio. Gli egittologi che iniziarono la compilazione della cronologia Egiziana non possedevano criteri oggettivi per la verifica delle loro ipotesi. Questo porta a grosse discrepanze tra le “differenti cronologie” dell’Egitto, che ammontano a 2-3 millenni, q.v. in Chron1, Capitolo 1. Le poche liste dinastiche che sono sopravvissute fin ad oggi, di tanto in tanto indicano la durata del regno di alcuni faraoni, ma spesso ci si riferisce ai faraoni con differenti nomi; in più, questi numeri cambiano drasticamente da lista a lista. Per esempio, Eusebio dà 26 anni di durata al regno di Amenmesse (seconda versione), come indicato in [544], laddove Africano dà 5 anni. Le durate differiscono tra loro di un fattore cinque. Eusebio indica 40 anni per Amenope (in entrambe le versioni), Africano indica 20, e Ophis solo 8. E così via. Tuttavia tutti questi dati possono fornire ancora almeno le basi per qualche speculazione, nonostante le ovvie e numerose distorsioni, e non fa meraviglia che gli Egittologi del XIX secolo abbiano tentato di utilizzare questi numeri per la costruzione di scale cronologiche. Comunque li loro calcoli erano afflitti da discrepanze di diversi millenni, come abbiamo visto sopra, per non parlare del concetto stesso errato della “storia allungata” Scaligeriana”. Comunque, per la maggior parte delle dinastie Egiziane, la durata dei regni dei faraoni rimane un completo mistero ([99], pagg. 725-730). L’intera sesta dinastia può essere citata come esempio (secondo Brugsch). Non ci sono dati cronologici per la maggior parte dei suoi faraoni, il che fa si che Brugsgh decida di assegnare una durata dei regni di 33.3 anni per ogni faraone di questa dinastia, contando 3 faraoni per secolo. Le sue datazioni della sesta dinastia sono come segue:
Userkaf – ha regnato dal 3300 A.C. in avanti,
Teti – dal 3266 A.C.,
Pepy I (Meryre) – dal 3233 A.C.,
Merenre – dal 3200 A.C.,
Neferkaf – dal 3166 A.C.,
Merenre Zafemzaf – dal 3133 A.C. (vedi [99], pag. 725).
Inoltre, Brugsh ha utilizzato esattamente lo stesso principio – numeri che terminavano con 00, 33, e 66, per la “datazione” di ogni dinastia a iniziare dalla prima e terminando con la ventiquattresima inclusa. Solo i faraoni delle ultime sette dinastie (su trenta!) hanno potuto godere di una qualche eterogeneità nella datazione dei loro regni ([99], pagg. 725-730). Questo “metodo di datazione” è così ridicolo che ci si sente imbarazzati a discuterne oggi. Nonostante ciò questo è proprio il metodo, con poche modificazioni più tarde, che la versione consensuale della cronologia Egiziana ha utilizzato. Le datazioni di Brugsch non sono nemmeno state rivedute. Vedi [1447], pag. 254, per esempio. La storia dinastica dell’Egitto è tutto fuorché continua. Alcuni degli intervalli che contiene ingoiano intere dinastie ([99] e [544], Volume 6). Allo stesso tempo, i ricercatori della “antica” storia Egiziana hanno notato che ha una sorprendente natura ciclica. La storia Scaligeriana dell’Egitto mostra uno strano “effetto rinascimento”, molto simile alla sua cugina Europea. Questo effetto ci è già noto – costantemente incontriamo duplicati fantasma degli stessi eventi medievali gettati nel lontano passato. Chantepie de la Saussaye, per citarne uno, scrive: “Se ci voltiamo alle età più tarde della storia Egiziana, saremo sorpresi di scoprire che la cultura Sais è l’immagine sputata della cultura dell’epoca delle piramidi. I testi utilizzati 3000 anni fa [sic! – A. F.] tornano di nuovo in circolazione, e ritorna l’antica moda di decorare le tombe”. ([966], pag. 99) H. Brugsch segnala quanto segue: “Come ha giustamente notato Mariett-Bey, i nomi tipici della dodicesima e specialmente della undicesima ritornano nei monumenti della diciottesima dinastia nella stessa forma precedente e sepolture simili con ornamentazione identica erano utilizzati in entrambi i periodi. Quello che abbiamo davanti è un enigma storico che purtroppo non abbiamo attualmente i mezzi per risolvere”. ([99], pag. 99) Gli egittologi trovano iscrizioni che si riferiscono a faraoni e re divisi da millenni nella cronologia Scaligeriana, che coesistono fianco a fianco sulle pareti dei templi Egiziani. Per cercare di trovare una qualche spiegazione, gli Egittologi hanno immaginato la seguente ipotesi: “I templi, costruiti recentemente dai sovrani Tolemaici e decorati dai Romani, sono tutti stati costruiti sui siti di antichi santuari; tutte le antiche iscrizioni trovate sulle pareti del tempio furono meticolosamente e devotamente copiate sulle pareti del nuovo tempio,” questo suggerisce Brugsch in [99], pag. 145. La pratica di copiare iscrizioni antiche e illeggibili dalle pareti di un antico tempio non è mai stata riscontrata in nessun altro periodo storico reale. Bisogna pensare che un simile nonsense non sia accaduto nemmeno nell’ “antico” Egitto. Tutte queste ripetizioni e rinascimenti hanno ricevuto una legittimazione e hanno guadagnato il titolo di “restaurazioni.” Ci viene raccontato, per esempio, che la diciannovesima dinastia era stata seguita da una restaurazione quando “l’Egitto… ritornò all’antica epoca della costruzione delle piramidi, che venne concepita come un’età degna di essere imitata. Gli antichi testi religiosi vengono resuscitati, sebbene la capacità degli Egiziani di capirli si suppone fosse limitata. I riti funerari della quarta dinastia vengono ripresi ancora una volta. Le loro piramidi sono restaurate; gli antichi titoli dei re che erano rimasti in completa oscurità per oltre un millennio vengono celebrati quotidianamente ancora una volta. L’arte ritorna alla solida, realistica maniera dell’Antico Regno” ([966], pag. 166). È ovvio che gli storici Scaligeriani debbano cercare una qualche spiegazione per queste bizzarre “ricorrenze di massa” di antichi riti, non riuscendo a riconoscerli come il prodotto del sistema di datazione erroneo che utilizzano. La “spiegazione” offerta dagli storici è il presunto estremo conservatorismo degli Egiziani. È scritto che “la restaurazione Sais può essere considerata come il periodo più significativo della storia della cultura Egiziana, e fornisce l’illustrazione migliore di quanto fosse conservativo lo spirito nazionale Egiziano” ([966], pag. 166). Questo è quello che ha da dire B. A. Turayev circa le “restaurazioni”: “I tentativi che abbiamo fatto per revisionare tutti i testi ufficiali che utilizzassero un linguaggio arcaico difficilmente comprensibile da molti… i dimenticati ranghi e gli uffici vengono resuscitati, le iscrizioni fatte durante quell’epoca, persino quelle private, possono essere prese per quelle fatte durante l’epoca dell’Antico Regno [sic! – A. F.]… . Il più tipico fenomeno è l’apparizione delle immagini sui lavori agricoli, scene pastorali, ecc., sulle pareti dei sepolcri che ci erano già familiari all’epoca dell’Antico Regno.” ([853], Volume 2, pagg. 102-103) Tutto ciò dopo duemila anni? Immaginate di dover scrivere una lettera a un amico utilizzando il linguaggio del I secolo A.C. Sembra una cosa molto difficile anche se uno lo volesse fare. La nuova cronologia elimina la necessità di inventare simili assurde spiegazioni. Evidentemente, non ci sono stati “rinascimenti globali” su una simile scala. N. A. Morozov ci fornisce un’analisi consecutiva di tutte e trenta le dinastie dei faraoni Egiziani. Arriva alla conclusione che praticamente quasi tutte le dinastie che precedono il IV secolo D.C. siano duplicati fantasma di diverse dinastie medievali. Eviteremo di citare qui le sue speculazioni. Non è sulle conclusioni di Morozov che la nostra ricerca si basa fondamentalmente, ma, piuttosto, la nostra ricerca matematica e statistica, qv nella bibliografia delle nostre pubblicazioni. La nostra ricerca ha mostrato come, tra le altre cose, N. A. Morozov era veramente lontano dal concludere la sua ricerca. Si era fermato a un’epoca troppo prematura – l’inizio del IV secolo D.C. – avendo aderito all’opinione erronea che la seguente epoca Egiziana non andasse rivista. E si sbagliava. Evidentemente, l’intero “Manuale Scaligeriano della Storia Egiziana” che precede il X-XII secolo D.C. è compilato con falsi duplicati della storia medievale dell’Egitto del XIII-XVII secolo D.C., come anche la storia del XIV-XVII secolo del Grande = impero Mongolo, qv in Chron5. Inoltre, la biblica “Terra d’Egitto” non chiaramente ha nulla a che vedere col territorio del moderno Egitto, poiché gli eventi Biblici Egiziani evidentemente ebbero luogo in posti assolutamente diversi. Vedi Chron6 per i dettagli.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
IL PROBLEMA DEI SECOLI BUI
di Anatoly Fomenko
Libro 4 della serie “History: Fiction or Science?”
7.3. Gli antichi Ittiti e i medievali Goti
È noto che gli “antichi Ittiti” vennero “scoperti” non prima del 1880, quando il professor Archibald Sayce fece una conferenza proclamando l’esistenza de “l’antica nazione degli Ittiti,” e basando la sua ricerca sull’analisi della Bibbia, q.v. in [291], pag. 21. Sayce guadagnò così il titolo di inventore degli Ittiti ([291]). Gli studi Biblici di Archibald Sayce e William Wright li portarono alla conclusione che gli “Ittiti” vivessero a nord della Terra Promessa Biblica. Essendo cresciuto nella storia Scaligeriana e aderendo all’erronea opinione che la Terra Promessa fosse situata nel territorio della odierna Palestina, Sayce e Wright confinarono gli “antichi Ittiti” in Asia Minore, che si trova a nord della Palestina. Però oggi cominciamo a capire che la Terra Promessa Biblica copre vasti territori nell’Europa del Sud e nelle terre Mediterranee, q.v. sopra in Chron6. Comunque, in questo caso, gli “Ittiti” sarebbero vissuti nell’Europa Meridionale nelle terre popolate dai Goti. Quello che vediamo qui è la sovrapposizione degli “antichi Ittiti” sui Goti medievali. Si possono così vedere le radici dell’errore di Sayce e Wright. Essi suggerirono di cercare reperti Ittiti nell’Asia Minore, che era il luogo della localizzazione sbagliata Scaligeriana del XVII secolo degli eventi Biblici, e non in Europa che era il posto dove si sarebbe dovuto cercarli poiché questi “Ittiti” era già perfettamente conosciuti col nome di Goti. Gli studi “Ittiti” furono condotti nello stesso modo della precedente ricerca Biblica, con gli archeologi che andavano in Asia Minore in cerca di rovine e trovando parecchio materiale da riferire agli “Ittiti.” In questo modo un altro errore della cronologia Scaligeriana venne “provato archeologicamente.”
8. Problemi relativi alla cronologia Scaligeriana dell’India
La storia Scaligeriana dell’Est è strettamente collegata alla storia dell’Europa e dell’Egitto come viene presentata da Scaligero e Petavio. Perciò, tutte le possibili alterazioni della cronologia Europea riguardano automaticamente la cronologia dell’ “antica” India. Facciamo un breve riassunto della cronologia Scaligeriana dell’India. Lo storico N. Gousseva scrive che “la scienza storica ha tali problemi in India che i ricercatori della storia antica di altri paesi e popoli non possono nemmeno immaginare [questa confessione fu fatta nel 1968 – A. F.]. La principale difficoltà è l’assoluta mancanza di monumenti datati” ([433], pag. 5). Evidentemente, tutti i principali “punti di riferimento cronologico” nella storia Indiana sono il prodotto di un’età più recente, e dipendono direttamente dalla precedente cronologia Scaligeriana di Roma, Grecia, e Egitto. Da qui l’ovvia necessità della revisione della storia Scaligeriana dell’India. Lo storico D. Kosambi riporta: “Non c’è praticamente nulla di quello che conosciamo come letteratura storica in India… tutto quello che abbiamo è una vaga tradizione orale e un numero molto ristretto di dati documentali, che sono quindi di maggior valore per noi di quelli ricevuti da leggende e miti. Questa tradizione non ci dà l’opportunità di ricostruire i nomi di tutti i sovrani. I magri resti in nostro possesso sono così nebulosi che non ci sono date prima del periodo Mussulmano [prima del VIII secolo D.C. – A. F.] che possono essere considerate precise… i lavori dei cronisti di corte non sono arrivati fino a noi; solo Cashmere e Camba possono essere visti in qualche modo come eccezioni… tutto ciò ha fatto dire a qualche serio e famoso scienziato che l’India non ha una storia propria” . ([433], pagg. 19-20). Per esempio, questo è ciò che dicono gli storici sull’ “antica” cultura della Valle dell’Indo: “ Oggi non possono ancora essere decifrati i memoriali scritti della cultura Indu… non un singolo ritrovamento può essere associato con una persona reale o un episodio storico. Non conosciamo nemmeno il linguaggio che veniva parlato dagli abitanti della Valle dell’Indo”. ([433], pagg. 65-66). Ci viene detto che la cronologia Scaligeriana dell’ “antica” India contiene vuoti di più di 600 anni ([433], pagg. 65-66). Come l’ “antica” Europa Scaligeriana, l’India “improvvisamente” scivola indietro nella barbarie intorno all’inizio della nuova era, e quindi “riprende” la sua ascensione alla “posizione di importanza” medievale; la quale è simile in modo sospetto al destino della cultura dell’ “antica” Europa, che si presume dimenticata da tutti e recuperata nuovamente nel Medio Evo. Il VII secolo D.C. è il periodo di questo presunto “rinascimento” piuttosto graduale della cultura Indiana Began, basata sulla cultura Ariana (probabilmente l’ideologia Cristiano-Ariana). I famosi “antichi” “ariani” Indiani possono evidentemente essere identificati come i Cristiani ariani del XII-XIV secolo, secondo la nostra ricostruzione. I misteriosi Ariani cominciarono a infestare l’età antidiluviana grazie alla cronologia Scaligeriana. Inoltre, si scopre che ([433]) i testi che riguardano il culto di Krishna in India sono di origine relativamente recente. Gli specialisti di storia delle religioni hanno da lungo tempo confermato l’esistenza di un vasto numero di paralleli tra Krishna e Cristo ([544], Volume 4). Questo è il motivo per cui certe affermazioni fatte dagli storici ultimi puzzano d’ambiguità, come “la completa biografia di Krishna non fu completata fino al XII secolo D.C. ” ([433], pag. 122). È possibile che il culto Indiano di Krishna non sia altro che il culto di Gesù, portato in India dai missionari Cristiani del XII-XIV secolo. Si presume che il dio Krishna venga citato nella Bibbia ([519], Volume 4, pag. 17). Secondo alcune fonti Indiane, il dio “Krishna” si può praticamente identificare con Cristo ([519], Volume 4). Gli autori medievali talvolta localizzano l’India in Africa o Italia (!). vedi altri dettagli In Chron5. Dobbiamo segnalare un altro fatto parecchio bizzarro della storia Scaligeriana a questo proposito. Si presume che l’ “antico” Alessandro il Grande abbia raggiunto l’India e sconfitto il re Indiano Porus, conquistando molte terre Indiane ([433]). Si potrebbe pensare che un evento di questo calibro potesse almeno lasciare qualche traccia nella storia Indiana. Tuttavia, non sembra questo il caso. “L’invasione… sembra non sia stata notata dalla tradizione Indiana, sebbene qualche storico straniero la consideri l’unico evento su larga scala dell’antica storia dell’India” ([433], pag. 143). Viene da farsi la domanda ovvia se l’India dei manoscritti medievali sia lo stesso paese della moderna India. Potrebbe darsi che sia un paese del tutto diverso quello che Alessandro ha Conquistato? Ci viene detto più avanti che molti problemi vitali concernenti l’ “antica” storia dell’India sono basati su manoscritti trovati non prima del XX secolo. Si scopre, per esempio, che “la principale fonte di conoscenza per quanto riguarda il sistema di governo dell’India e la politica dello stato nell’epoca dell’ascensione di Maghadhi è il libro Arthashastra – il libro… trovato solo nel 1905, dopo molti secoli di completo oblio” ([433], pag. 146). Si scopre che questo libro è fondamentalmente la versione Indiana della famosa opera medievale di Machiavelli. Comunque, in questo caso l’ “antico Arthashastra Indiano” non potrebbe essere stato scritto prima del Rinascimento. Questo può essere accaduto nel XVII-XVIII secolo, o anche nel XIX. La storia Scaligeriana dell’India ricorda la sua cugina Europea perché ripiombò nella barbarie all’inizio della nuova era, e dovette “riprendere” la sua “lunga ascesa alle vette della civilizzazione” ([433]). Ci viene anche detto che “l’unica rilevante iscrizione in Sanscrito fu trovata a Ghirnar e datata grossomodo al 150 D.C.” ([433], pag. 172). Comunque, immediatamente scopriamo che il culmine della letteratura Sanscrita in India iniziò intorno al XI secolo D.C. Questo è probabilmente il risultato dello slittamento cronologico di mille anni che già conosciamo bene. A proposito, potrebbe la parola “Sanscrito” stare per “Santo Scritto,” o Sacra Scrittura? La storia Scaligeriana dell’India medievale contiene anche un gran numero di vuoti cronologici centenari, ed è confusa e caotica. “L’apatia dei Bramini a qualunque cosa di reale nel passato e nel presente … ha cancellato la storia dell’India dalla memoria umana… per ricostruire la storia e le realtà … dell’antica India … dobbiamo riferirci ai resoconti dei geografi Greci e viaggiatori Arabi … non c’è una singola fonte Indiana che possa equiparare in valore i resoconti degli stranieri”. ([433], pag. 180). Perciò, la storia Scaligeriana dell’India dipende completamente dalla cronologia consensuale di Roma e della Grecia e dovrà quindi essere ricostruita. Gli storici caratterizzano la storia dinastica dell’India nello stesso modo: “I nomi individuali dei Re sono oscurati dalla pittoresca nebbia delle leggende. Non abbiamo nulla che possa lontanamente assomigliare alle cronache di palazzo” ([433], pag. 192). Non riusciamo a vedere la pittoresca nebbia storica. Potrebbe risiedere nella libertà che concede alla fantasia di ognuno? Il famoso Mahabharata, una collezione di “antiche” epopee Indiane, viene relegato a una distante epoca A.C. dagli storici Scaligeriani. Dall’altro lato, il lavoro si suppone basato sulle “antiche” epopee Greche. Un gran numero di paralleli tra il Mahabharata e i poemi di Omero furono scoperti un po’ di tempo fa ([519]). Gli storici affermano che gli Indiani stavano “riformulando Omero” ([520], pag. 13). Se questo è il caso, la datazione del Mahabharata diventa completamente dipendente dalle datazioni del poema scritto dall’ “antico” Omero. Abbiamo già dimostrato che gli eventi occorsi nell’ “antica” Grecia erano in realtà probabilmente medievali, cioè, datati al XIII-XVI secolo D.C. Una più approfondita analisi del Mahabharata, il grande corpo del testo epico, in linea con quanto visto per la nuova Cronologia, viene realizzata nel nostro nuovo libro intitolato “La Cronologia dell’India. La Geografia di Tolomeo’. L’ ‘Atlante’ di Ortelius, 2003.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.