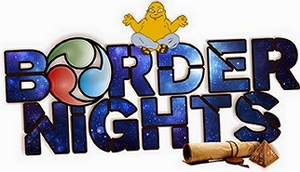- Messaggi: 599
- Ringraziamenti ricevuti 20
Artigiano, guerriero e mago: i tre archetipi iniziatici
7 Mesi 1 Settimana fa #62171
da Bastion
Artigiano, guerriero e mago: i tre archetipi iniziatici è stato creato da Bastion
ARTIGIANO, GUERRIERO E MAGO: I TRE ARCHETIPI INIZIATICI
Angel Mirral
Quando Pierre Boulle scrisse il suo romanzo La Planète des singes all'inizio degli anni '60, aveva senza dubbio osservato la strana divisione tra mente e corpo nella società occidentale moderna, riflettendola nel romanzo che sarebbe diventato il primo film "Il pianeta delle scimmie", uscito nel 1968. Il film ci mostrava un mondo governato dalle scimmie e una società scimmiesca divisa in diverse caste, ciascuna con una propria funzione: gli scimpanzé (scienziati), i gorilla (militari e polizia) e gli oranghi (politici o leader). Probabilmente senza volerlo, Boulle aveva evocato e reimmaginato gli archetipi alla base della civiltà umana: l'Artigiano, il Guerriero e il Mago. Ma aveva notato anche qualcos'altro.
In "Il pianeta delle scimmie", le differenze tra i gorilla forti e militaristi e gli scimpanzé effeminati e intellettuali causavano una divisione nella società, con sospetti da entrambe le parti. Questo deve aver trovato riscontro nell'America di allora, in guerra in Vietnam e teatro di proteste contro il conflitto. L'anno prima dell'uscita del film, durante la Marcia sul Pentagono, i manifestanti avevano offerto fiori a 2.500 soldati della Guardia Nazionale o li avevano infilati nelle canne dei fucili dei soldati. Come riflesso della società umana, "Il pianeta delle scimmie" era quindi troppo precoce per notare la straordinaria aggressività della classe intellettuale, un'aggressività che eguaglia quella della classe militare, ma che è diretta contro la società degli intellettuali stessi piuttosto che verso un nemico esterno.
In una società del genere, le teorie dominano i fatti e le idee dettano la realtà. La professione medica potrebbe dirci che, come l'anoressia, l'obesità è associata a gravi rischi per la salute, ma sottolinearlo in pubblico potrebbe essere considerato "sizeism" o "incitamento all'odio". Negli Stati Uniti, alcuni anni fa, si è cercato di convincere l'opinione pubblica che il "lookismo" era il nuovo razzismo. Secondo questa teoria (ancora sostenuta da molti attivisti), poiché siamo attratti dalla bellezza ma non tanto dalla bruttezza, la bellezza è oppressiva in quanto deve essere socialmente costruita. Se la bellezza nelle donne è sospetta nell'era attuale, lo è naturalmente anche la forza fisica negli uomini. Nel 2017, la polizia del Bedfordshire ha twittato un meme che associava l'andare in palestra all'estremismo di destra. E probabilmente tutti noi possiamo pensare a teorie sempre più popolari che ci dicono che i nostri corpi naturali sono poco più che grumi di plastilina che, anche durante l'infanzia, possono essere manipolati attraverso farmaci e interventi chirurgici per assumere forme nuove e interessanti, che presumibilmente rappresentano chi siamo veramente, o chi diciamo di essere.
Tre archetipi
In un'epoca di confusione, crescente preoccupazione per la sicurezza, crescente scetticismo nei confronti del trascendente e crescente squilibrio negli individui e nella società nel suo complesso, abbiamo più che mai da imparare dagli archetipi dell'artigiano, del guerriero e del mago. Ma perché non altri archetipi?
Negli ultimi decenni, tutto, dal marketing all'analisi dei film, è stato influenzato dalla nozione di archetipi dello psicoanalista Carl Jung. Sono stati creati vari nuovi raggruppamenti di archetipi (ad esempio, i dodici "archetipi di marca" dell'industria del marketing). Considerati rappresentativi della natura autentica e primordiale degli esseri umani, alcuni di questi "archetipi" proposti non hanno alcun ruolo significativo nei miti antichi (forse la fonte primaria di Jung per l'esplorazione degli archetipi) né alcun ruolo nella cultura umana primitiva (o anche in quella successiva). L'innocente, l'orfano, il giullare e l'amante compaiono tutti come "archetipi" in alcune teorie. Eppure, non è mai esistita una tribù o una società di giullari, guerrieri e amanti, per esempio.
Quando osserviamo le culture antiche, vediamo – come sosteneva il filologo comparato e mitologo Georges Dumézil – gli artigiani, i guerrieri e i maghi raggruppati insieme più e più volte. Secondo Dumézil, questi costituivano le tre classi o caste originarie delle società indoeuropee e, come tali, si diffusero in Europa, India, Persia e altrove, anche se, in ultima analisi, troviamo queste caste in tutto il mondo.
Che crediamo che l'esistenza di queste tre caste sia il risultato di archetipi impressi nella coscienza della società o che sia dovuta a legami storici tra l'antica India e la Grecia, ad esempio, è certo che (a differenza di altri raggruppamenti puramente arbitrari, come giullari, guerrieri, amanti, per esempio) nessuna società è mai stata in grado di sopravvivere senza artigiani (fabbri, contadini, ecc.), guerrieri e maghi (anziani del villaggio, guide, leader spirituali e intellettuali, ecc.).
Pochi sanno che Platone era un abile lottatore.
Sebbene non sia sorprendente trovare questi elementi nelle società primitive, è sorprendente che questo gruppo riappaia in seguito, sia in Oriente che in Occidente. Il filosofo greco Platone non solo era stato iniziato ai Misteri, ma era anche noto per la sua abilità nella lotta (il suo nome significa letteralmente "spallaccione"). Egli insegnava che non solo la filosofia (l'archetipo del mago) era necessaria, ma anche lo studio della musica (l'artigiano) e la disciplina fisica (il guerriero). Ancora una volta, Miyamoto Musashi, il guerriero più famoso del Giappone, trascorse anni meditando in una grotta (archetipo del mago) ed era anche noto per la sua abilità nella pittura, nella calligrafia e nel giardinaggio (l'artigiano). E dall'educazione confuciana a quella classica occidentale, inevitabilmente c'è un mix di studio della filosofia, dei rituali e della religione (mago), della musica, della calligrafia, della pittura (artigiano) e della scherma, della lotta, della boxe o di sport fisicamente impegnativi e pericolosi (guerriero).
Ancora una volta, intorno al XII secolo d.C., gli ordini sufi non solo furono influenzati dalla cavalleria islamica (futuwwa), ma cominciarono a strutturarsi secondo il modello delle corporazioni di mestiere, con i discepoli che diventavano apprendisti (mubtadi'), compagni (sani') e maestri artigiani (mu'allim). Circa seicento anni dopo, in Inghilterra, la confraternita dei Liberi Muratori (o Massoneria) si separò dalla corporazione dei muratori della Gran Bretagna. Si espanse sui due rituali di iniziazione della corporazione dei muratori e ne aggiunse un terzo in modo che, nella "Loggia Massonica", un massone diventasse un apprendista, poi un compagno e infine un maestro massone.
Ci sono anche accenni alla cavalleria nei gradi della Massoneria operativa. Il grembiule bianco, consegnato a ogni massone, è descritto nel rituale massonico come "più onorevole della Stella e dell'Ordine della Giarrettiera", un riferimento all'Ordine cavalleresco della Giarrettiera. Tuttavia, il guerriero - o più specificamente il cavaliere - è più pronunciato nei cosiddetti "gradi superiori" della Massoneria. Quando la confraternita massonica si diffuse in Francia e Germania circa un decennio dopo la fondazione della prima Gran Loggia a Londra, nel 1717 d.C., gli appassionati di massoneria iniziarono a creare nuovi gradi. Alcuni furono influenzati dall'alchimia, dall'ermetismo o dal rosacrocianesimo, ma quasi tutti furono influenzati dalla cavalleria cristiana.
Sebbene probabilmente non fosse a conoscenza della divisione nella cultura antica tra artigiani, guerrieri e maghi, nel suo libro Masonic Temples lo storico William D. Moore sosteneva che la massoneria americana fosse arrivata a incarnare l'artigiano, il guerriero sacro e il mistico. Per Moore, la Loggia Massonica incarna l'archetipo dell'artigiano, l'Ordine Massonico del Tempio (o grado dei "Cavalieri Templari") incarna il guerriero e i gradi della Massoneria di Rito Scozzese incarnano il mago.
Proprio come troviamo tre livelli o gradi nel Sufismo e nella Massoneria, l'antropologo David W. Anthony ha suggerito che, nell'antichità, le vocazioni di artigiano, guerriero e mago (saggio, sacerdote o anziano, ecc.) costituivano "tre gradi di età", con un uomo che passava dall'essere un artigiano in gioventù (nelle culture premoderne le persone spesso iniziavano a lavorare all'età di cinque o sei anni o anche prima), diventando un guerriero durante gli anni di massimo vigore fisico e un mago o capo tribù in età avanzata. Certamente, questa progressione ha senso. Nessuna società normale, dopotutto, vorrebbe anziani per la propria protezione o bambini come leader. Tuttavia, incarnando sia la società umana primitiva che una progressione archetipica dall'infanzia all'età adulta, dal lavoro alla guida spirituale, forse era inevitabile che l'artigiano, il guerriero e il mago (e non il giullare, il guerriero, l'amante, per esempio) riemergessero nelle società successive con l'intento di iniziare gli uomini, in particolare, alla virilità e a una realtà trascendente al di là della routine quotidiana.
Incorporare gli archetipi nella propria vita
Tuttavia, come Platone e Musashi, non dobbiamo aspettare di passare da un archetipo all'altro. Al contrario, come suggerisce l'educazione classica orientale e occidentale, possiamo e dobbiamo trovare il modo di incorporarli nella nostra vita fin da ora. Questo è particolarmente importante oggi. In equilibrio con artigiani, guerrieri e maghi o guide spirituali, la società antica era olistica, completa; il corpo, il cervello e lo spirito erano in equilibrio. Oggi, invece, la mente e il corpo sono così profondamente divisi in Occidente che siamo arrivati a considerare il corpo fisico come qualcosa che non ha alcuna realtà oggettiva al di là di ciò che la mente (cioè l'ultima teoria intellettuale) dice che sia.E con il declino della religione in Occidente, è diminuito anche il senso del sacro e del trascendente. Eppure, il fervore religioso è vivo e vegeto in politica. Se mettiamo apertamente in discussione le ultime dichiarazioni della casta dei sacerdoti politici, saremo denunciati come eretici.
In che modo gli archetipi dell'artigiano, del guerriero e del mago possono aiutarci? Sebbene esistano delle differenze tra loro, come abbiamo suggerito, ci sono anche connessioni e sovrapposizioni. In molte società tribali antiche, i fabbri fungevano da sacerdoti o sciamani, eseguendo riti speciali e iniziando i nuovi membri all'arte della metallurgia. Anche il guerriero aveva i suoi riti spirituali e le sue tradizioni. In India, un santuario dedicato alla dea Kali è conservato nel tempio tradizionale dell'arte marziale del Kalaripayattu. In Iran, la tradizione marziale dello Zoorkhana è stata fortemente influenzata dal sufismo e dall'Islam sciita. Il Kung Fu Shaolin proviene dal monastero buddista di Shaolin. Ancora una volta, il buddismo zen è stato associato ai samurai e alle arti marziali come il kendo e il karate-do, ma lo zen era anche insegnato attraverso, o incarnato in, l'artigianato o le arti della pittura, della calligrafia, dell'arte floreale e persino del servizio del tè (chado). Non sorprende, forse, che il manuale samurai Hagakure ci dica che se un praticante di una Via (un Do o Tao) dovesse vedere un altro praticante della Via, dovrebbe comprendere ancora più chiaramente la propria.
Nonostante ciò che i nostri sistemi educativi e lavorativi attualmente promuovono, non dobbiamo rimanere bloccati in una specializzazione o in un modo di pensare limitato. Nella maggior parte dei casi, anche se trovare una nicchia può funzionare, è probabile che funzioni solo per un periodo di tempo limitato, soprattutto in un mondo in rapida evoluzione. La flessibilità è necessaria. Inoltre, anche oggi, i leader in qualsiasi campo pensano fuori dagli schemi e mettono insieme cose diverse, apparentemente incompatibili. (Si pensi a Steve Jobs che ha introdotto diversi tipi di carattere nei computer ispirandosi al suo studio dell'antica arte della calligrafia sotto la guida di un monaco trappista). La specializzazione, o compartimentazione, è un problema ancora più grande quando si tratta della nostra vita. Nella migliore delle ipotesi, ci incoraggia a diventare una frazione di ciò che potremmo essere. Nella maggior parte dei casi, trasforma le persone in hobbisti, consumatori ossessivi di programmi sportivi televisivi o fantasiosi spirituali e pseudo-intellettuali con un senso esagerato della propria bontà morale e della malvagità di tutti gli altri.
Invece, come sostengo nel mio libro The Three Stages of Initiatic Spirituality: Craftsman, Warrior, Magician, dobbiamo coltivare la mente, il corpo e lo spirito, praticando qualche forma d'arte o abilità, allenando il corpo e avendo una qualche forma di spiritualità. Per Platone questo significava musica, lotta e filosofia. Per noi, potrebbe significare qualsiasi cosa, dalla pittura, alla scrittura, alla poesia, alla personalizzazione di motociclette, all'imparare a cucinare cibi tradizionali e sani (artigiano); allenarsi in palestra, praticare un'arte marziale o partecipare a gare spartane, ecc. (guerriero); e praticare la meditazione, il pensiero positivo, qualche tipo di rituale spirituale o religioso, o studiare i simboli, i miti e gli archetipi incarnati nelle culture antiche del mondo (mago).
Come siamo arrivati dove siamo oggi
Come siamo passati da una società tribale e antica, in cui artigiani, guerrieri, maghi o anziani e leader spirituali vivevano in armonia, a una in cui le diverse fazioni sono in guerra tra loro e, in alcuni casi, in guerra con le proprie società? L'allontanamento dalla natura potrebbe essere una delle ragioni. Un'altra potrebbe essere la mancanza di conoscenza del passato. Ma, senza dubbio, dall'era industriale a quella post-industriale, la specializzazione nell'istruzione e nel lavoro ha avuto un ruolo importante. Non possiamo e non riusciamo a passare dall'essere esperti in un'arte o in un mestiere, a diventare guerrieri, per poi diventare finalmente guide per la comunità.
La mitologia e la sociologia antica spiegano la trasformazione della società in un altro modo. Ci sono due serie di miti contrastanti che dobbiamo considerare. Secondo una serie di miti, il mondo e la qualità dell'umanità sono in declino, diventando sempre meno spirituali e sempre più materialisti ed egocentrici. Secondo l'altra serie di miti, c'è un progresso naturale e forse inarrestabile. Il primo gruppo di miti tende a concentrarsi sulla società (la società è in declino), mentre i miti del progresso tendono a concentrarsi sull'individuo (l'individuo ha più libertà e può essere più creativo).
Uno dei primi miti sul progresso dell'umanità fu creato da Gioacchino della Fiori (1135-1202 circa). Gioacchino fu il fondatore di un proprio ordine monastico e uno dei più importanti teorici storici e apocalittici del Medioevo. Egli concepì tre grandi ere: l'era del Padre, l'era del Figlio e l'era dello Spirito Santo. Di conseguenza, nella prima di queste ere, le persone vivevano sotto la Legge e servivano Dio. Durante la seconda era, le persone vivevano sotto il Vangelo, anche se Cristo aveva dato la libertà all'umanità. Solo nell'ultima era, tuttavia, ci sarebbe stata la piena libertà. Uno schema simile è stato elaborato dall'occultista inglese Aleister Crowley (1875-1947), che concepiva il tempo come divisibile in Eoni di Iside, Osiride e Horus, con l'umanità che avrebbe finalmente acquisito la libertà e l'individualità nell'ultimo.
Al contrario, secondo la tradizione indù, ci sono quattro grandi ere o Yuga, che iniziano con il Satya Yuga (l'era della verità) e terminano con il Kali Yuga (l'era oscura). Allo stesso modo, l'antico poeta greco Esiodo sosteneva che gli dei avessero creato diverse "razze". La prima di queste era una razza di persone dorate. Vivevano in armonia con la natura e tra loro e godevano di una vita lunga e sana. Poi vennero una razza d'argento e una di bronzo e infine una di ferro. Anche la mitologia norrena narra che agli albori della terra gli dei possedevano oro in abbondanza (a simboleggiare un'età dell'oro). Alla fine, però, ci fu una guerra cosmica tra gli dei e i giganti. In tutti e tre i miti, l'era finale era - o sarà - descritta in termini quasi identici: i fratelli combatteranno tra loro, i genitori saranno disonorati, gli uomini e le donne si uniranno solo per desiderio sessuale, gli uomini potenti e corrotti saranno rispettati.
Sebbene non fosse interessato a questi miti, Ibn Khaldun sosteneva che un tale declino fosse del tutto reale. Nato a Tunisi nel 1332, Ibn Khaldun è spesso considerato il padre della sociologia. Durante la sua vita, fu testimone dell'ascesa e della caduta di dinastie in tutto il Nord Africa. Riflettendo su questo, affermò che ogni dinastia attraversa tre fasi. Nella prima fase, una banda di guerrieri piomba su un regno, lo sconfigge e lo conquista. In questa prima fase, i guerrieri, sebbene vittoriosi, rimangono fedeli ai valori del deserto. Non si curano del lusso e dormono per terra. Nella fase successiva, il popolo gode del lusso del regno, ma spera di tornare a uno stile di vita più rude, che ammira. Nella fase finale, il popolo ama il lusso, è debole e cerca protezione dal sovrano. Incapace di difendersi, una nuova banda di guerrieri piomba su di esso e lo conquista, ricominciando il ciclo.
Potremmo trovare un'immagine della nostra civiltà da qualche parte nello schema di Ibn Khaldun. Ovunque ci collochiamo al suo interno, l'implicazione è sicuramente che né il lusso e la sicurezza né il guerriero da soli sono sufficienti per creare o sostenere una civiltà. Al contrario, come forse in ogni società premoderna di successo, è necessario un rapporto armonioso tra l'artigiano, il guerriero e il mago. Se la civiltà che ci circonda non è in grado di farlo, noi, individualmente, possiamo e dobbiamo incarnare e unificare questi archetipi nella nostra vita.
Angel Mirral
Quando Pierre Boulle scrisse il suo romanzo La Planète des singes all'inizio degli anni '60, aveva senza dubbio osservato la strana divisione tra mente e corpo nella società occidentale moderna, riflettendola nel romanzo che sarebbe diventato il primo film "Il pianeta delle scimmie", uscito nel 1968. Il film ci mostrava un mondo governato dalle scimmie e una società scimmiesca divisa in diverse caste, ciascuna con una propria funzione: gli scimpanzé (scienziati), i gorilla (militari e polizia) e gli oranghi (politici o leader). Probabilmente senza volerlo, Boulle aveva evocato e reimmaginato gli archetipi alla base della civiltà umana: l'Artigiano, il Guerriero e il Mago. Ma aveva notato anche qualcos'altro.
In "Il pianeta delle scimmie", le differenze tra i gorilla forti e militaristi e gli scimpanzé effeminati e intellettuali causavano una divisione nella società, con sospetti da entrambe le parti. Questo deve aver trovato riscontro nell'America di allora, in guerra in Vietnam e teatro di proteste contro il conflitto. L'anno prima dell'uscita del film, durante la Marcia sul Pentagono, i manifestanti avevano offerto fiori a 2.500 soldati della Guardia Nazionale o li avevano infilati nelle canne dei fucili dei soldati. Come riflesso della società umana, "Il pianeta delle scimmie" era quindi troppo precoce per notare la straordinaria aggressività della classe intellettuale, un'aggressività che eguaglia quella della classe militare, ma che è diretta contro la società degli intellettuali stessi piuttosto che verso un nemico esterno.
In una società del genere, le teorie dominano i fatti e le idee dettano la realtà. La professione medica potrebbe dirci che, come l'anoressia, l'obesità è associata a gravi rischi per la salute, ma sottolinearlo in pubblico potrebbe essere considerato "sizeism" o "incitamento all'odio". Negli Stati Uniti, alcuni anni fa, si è cercato di convincere l'opinione pubblica che il "lookismo" era il nuovo razzismo. Secondo questa teoria (ancora sostenuta da molti attivisti), poiché siamo attratti dalla bellezza ma non tanto dalla bruttezza, la bellezza è oppressiva in quanto deve essere socialmente costruita. Se la bellezza nelle donne è sospetta nell'era attuale, lo è naturalmente anche la forza fisica negli uomini. Nel 2017, la polizia del Bedfordshire ha twittato un meme che associava l'andare in palestra all'estremismo di destra. E probabilmente tutti noi possiamo pensare a teorie sempre più popolari che ci dicono che i nostri corpi naturali sono poco più che grumi di plastilina che, anche durante l'infanzia, possono essere manipolati attraverso farmaci e interventi chirurgici per assumere forme nuove e interessanti, che presumibilmente rappresentano chi siamo veramente, o chi diciamo di essere.
Tre archetipi
In un'epoca di confusione, crescente preoccupazione per la sicurezza, crescente scetticismo nei confronti del trascendente e crescente squilibrio negli individui e nella società nel suo complesso, abbiamo più che mai da imparare dagli archetipi dell'artigiano, del guerriero e del mago. Ma perché non altri archetipi?
Negli ultimi decenni, tutto, dal marketing all'analisi dei film, è stato influenzato dalla nozione di archetipi dello psicoanalista Carl Jung. Sono stati creati vari nuovi raggruppamenti di archetipi (ad esempio, i dodici "archetipi di marca" dell'industria del marketing). Considerati rappresentativi della natura autentica e primordiale degli esseri umani, alcuni di questi "archetipi" proposti non hanno alcun ruolo significativo nei miti antichi (forse la fonte primaria di Jung per l'esplorazione degli archetipi) né alcun ruolo nella cultura umana primitiva (o anche in quella successiva). L'innocente, l'orfano, il giullare e l'amante compaiono tutti come "archetipi" in alcune teorie. Eppure, non è mai esistita una tribù o una società di giullari, guerrieri e amanti, per esempio.
Quando osserviamo le culture antiche, vediamo – come sosteneva il filologo comparato e mitologo Georges Dumézil – gli artigiani, i guerrieri e i maghi raggruppati insieme più e più volte. Secondo Dumézil, questi costituivano le tre classi o caste originarie delle società indoeuropee e, come tali, si diffusero in Europa, India, Persia e altrove, anche se, in ultima analisi, troviamo queste caste in tutto il mondo.
Che crediamo che l'esistenza di queste tre caste sia il risultato di archetipi impressi nella coscienza della società o che sia dovuta a legami storici tra l'antica India e la Grecia, ad esempio, è certo che (a differenza di altri raggruppamenti puramente arbitrari, come giullari, guerrieri, amanti, per esempio) nessuna società è mai stata in grado di sopravvivere senza artigiani (fabbri, contadini, ecc.), guerrieri e maghi (anziani del villaggio, guide, leader spirituali e intellettuali, ecc.).
Pochi sanno che Platone era un abile lottatore.
Sebbene non sia sorprendente trovare questi elementi nelle società primitive, è sorprendente che questo gruppo riappaia in seguito, sia in Oriente che in Occidente. Il filosofo greco Platone non solo era stato iniziato ai Misteri, ma era anche noto per la sua abilità nella lotta (il suo nome significa letteralmente "spallaccione"). Egli insegnava che non solo la filosofia (l'archetipo del mago) era necessaria, ma anche lo studio della musica (l'artigiano) e la disciplina fisica (il guerriero). Ancora una volta, Miyamoto Musashi, il guerriero più famoso del Giappone, trascorse anni meditando in una grotta (archetipo del mago) ed era anche noto per la sua abilità nella pittura, nella calligrafia e nel giardinaggio (l'artigiano). E dall'educazione confuciana a quella classica occidentale, inevitabilmente c'è un mix di studio della filosofia, dei rituali e della religione (mago), della musica, della calligrafia, della pittura (artigiano) e della scherma, della lotta, della boxe o di sport fisicamente impegnativi e pericolosi (guerriero).
Ancora una volta, intorno al XII secolo d.C., gli ordini sufi non solo furono influenzati dalla cavalleria islamica (futuwwa), ma cominciarono a strutturarsi secondo il modello delle corporazioni di mestiere, con i discepoli che diventavano apprendisti (mubtadi'), compagni (sani') e maestri artigiani (mu'allim). Circa seicento anni dopo, in Inghilterra, la confraternita dei Liberi Muratori (o Massoneria) si separò dalla corporazione dei muratori della Gran Bretagna. Si espanse sui due rituali di iniziazione della corporazione dei muratori e ne aggiunse un terzo in modo che, nella "Loggia Massonica", un massone diventasse un apprendista, poi un compagno e infine un maestro massone.
Ci sono anche accenni alla cavalleria nei gradi della Massoneria operativa. Il grembiule bianco, consegnato a ogni massone, è descritto nel rituale massonico come "più onorevole della Stella e dell'Ordine della Giarrettiera", un riferimento all'Ordine cavalleresco della Giarrettiera. Tuttavia, il guerriero - o più specificamente il cavaliere - è più pronunciato nei cosiddetti "gradi superiori" della Massoneria. Quando la confraternita massonica si diffuse in Francia e Germania circa un decennio dopo la fondazione della prima Gran Loggia a Londra, nel 1717 d.C., gli appassionati di massoneria iniziarono a creare nuovi gradi. Alcuni furono influenzati dall'alchimia, dall'ermetismo o dal rosacrocianesimo, ma quasi tutti furono influenzati dalla cavalleria cristiana.
Sebbene probabilmente non fosse a conoscenza della divisione nella cultura antica tra artigiani, guerrieri e maghi, nel suo libro Masonic Temples lo storico William D. Moore sosteneva che la massoneria americana fosse arrivata a incarnare l'artigiano, il guerriero sacro e il mistico. Per Moore, la Loggia Massonica incarna l'archetipo dell'artigiano, l'Ordine Massonico del Tempio (o grado dei "Cavalieri Templari") incarna il guerriero e i gradi della Massoneria di Rito Scozzese incarnano il mago.
Proprio come troviamo tre livelli o gradi nel Sufismo e nella Massoneria, l'antropologo David W. Anthony ha suggerito che, nell'antichità, le vocazioni di artigiano, guerriero e mago (saggio, sacerdote o anziano, ecc.) costituivano "tre gradi di età", con un uomo che passava dall'essere un artigiano in gioventù (nelle culture premoderne le persone spesso iniziavano a lavorare all'età di cinque o sei anni o anche prima), diventando un guerriero durante gli anni di massimo vigore fisico e un mago o capo tribù in età avanzata. Certamente, questa progressione ha senso. Nessuna società normale, dopotutto, vorrebbe anziani per la propria protezione o bambini come leader. Tuttavia, incarnando sia la società umana primitiva che una progressione archetipica dall'infanzia all'età adulta, dal lavoro alla guida spirituale, forse era inevitabile che l'artigiano, il guerriero e il mago (e non il giullare, il guerriero, l'amante, per esempio) riemergessero nelle società successive con l'intento di iniziare gli uomini, in particolare, alla virilità e a una realtà trascendente al di là della routine quotidiana.
Incorporare gli archetipi nella propria vita
Tuttavia, come Platone e Musashi, non dobbiamo aspettare di passare da un archetipo all'altro. Al contrario, come suggerisce l'educazione classica orientale e occidentale, possiamo e dobbiamo trovare il modo di incorporarli nella nostra vita fin da ora. Questo è particolarmente importante oggi. In equilibrio con artigiani, guerrieri e maghi o guide spirituali, la società antica era olistica, completa; il corpo, il cervello e lo spirito erano in equilibrio. Oggi, invece, la mente e il corpo sono così profondamente divisi in Occidente che siamo arrivati a considerare il corpo fisico come qualcosa che non ha alcuna realtà oggettiva al di là di ciò che la mente (cioè l'ultima teoria intellettuale) dice che sia.E con il declino della religione in Occidente, è diminuito anche il senso del sacro e del trascendente. Eppure, il fervore religioso è vivo e vegeto in politica. Se mettiamo apertamente in discussione le ultime dichiarazioni della casta dei sacerdoti politici, saremo denunciati come eretici.
In che modo gli archetipi dell'artigiano, del guerriero e del mago possono aiutarci? Sebbene esistano delle differenze tra loro, come abbiamo suggerito, ci sono anche connessioni e sovrapposizioni. In molte società tribali antiche, i fabbri fungevano da sacerdoti o sciamani, eseguendo riti speciali e iniziando i nuovi membri all'arte della metallurgia. Anche il guerriero aveva i suoi riti spirituali e le sue tradizioni. In India, un santuario dedicato alla dea Kali è conservato nel tempio tradizionale dell'arte marziale del Kalaripayattu. In Iran, la tradizione marziale dello Zoorkhana è stata fortemente influenzata dal sufismo e dall'Islam sciita. Il Kung Fu Shaolin proviene dal monastero buddista di Shaolin. Ancora una volta, il buddismo zen è stato associato ai samurai e alle arti marziali come il kendo e il karate-do, ma lo zen era anche insegnato attraverso, o incarnato in, l'artigianato o le arti della pittura, della calligrafia, dell'arte floreale e persino del servizio del tè (chado). Non sorprende, forse, che il manuale samurai Hagakure ci dica che se un praticante di una Via (un Do o Tao) dovesse vedere un altro praticante della Via, dovrebbe comprendere ancora più chiaramente la propria.
Nonostante ciò che i nostri sistemi educativi e lavorativi attualmente promuovono, non dobbiamo rimanere bloccati in una specializzazione o in un modo di pensare limitato. Nella maggior parte dei casi, anche se trovare una nicchia può funzionare, è probabile che funzioni solo per un periodo di tempo limitato, soprattutto in un mondo in rapida evoluzione. La flessibilità è necessaria. Inoltre, anche oggi, i leader in qualsiasi campo pensano fuori dagli schemi e mettono insieme cose diverse, apparentemente incompatibili. (Si pensi a Steve Jobs che ha introdotto diversi tipi di carattere nei computer ispirandosi al suo studio dell'antica arte della calligrafia sotto la guida di un monaco trappista). La specializzazione, o compartimentazione, è un problema ancora più grande quando si tratta della nostra vita. Nella migliore delle ipotesi, ci incoraggia a diventare una frazione di ciò che potremmo essere. Nella maggior parte dei casi, trasforma le persone in hobbisti, consumatori ossessivi di programmi sportivi televisivi o fantasiosi spirituali e pseudo-intellettuali con un senso esagerato della propria bontà morale e della malvagità di tutti gli altri.
Invece, come sostengo nel mio libro The Three Stages of Initiatic Spirituality: Craftsman, Warrior, Magician, dobbiamo coltivare la mente, il corpo e lo spirito, praticando qualche forma d'arte o abilità, allenando il corpo e avendo una qualche forma di spiritualità. Per Platone questo significava musica, lotta e filosofia. Per noi, potrebbe significare qualsiasi cosa, dalla pittura, alla scrittura, alla poesia, alla personalizzazione di motociclette, all'imparare a cucinare cibi tradizionali e sani (artigiano); allenarsi in palestra, praticare un'arte marziale o partecipare a gare spartane, ecc. (guerriero); e praticare la meditazione, il pensiero positivo, qualche tipo di rituale spirituale o religioso, o studiare i simboli, i miti e gli archetipi incarnati nelle culture antiche del mondo (mago).
Come siamo arrivati dove siamo oggi
Come siamo passati da una società tribale e antica, in cui artigiani, guerrieri, maghi o anziani e leader spirituali vivevano in armonia, a una in cui le diverse fazioni sono in guerra tra loro e, in alcuni casi, in guerra con le proprie società? L'allontanamento dalla natura potrebbe essere una delle ragioni. Un'altra potrebbe essere la mancanza di conoscenza del passato. Ma, senza dubbio, dall'era industriale a quella post-industriale, la specializzazione nell'istruzione e nel lavoro ha avuto un ruolo importante. Non possiamo e non riusciamo a passare dall'essere esperti in un'arte o in un mestiere, a diventare guerrieri, per poi diventare finalmente guide per la comunità.
La mitologia e la sociologia antica spiegano la trasformazione della società in un altro modo. Ci sono due serie di miti contrastanti che dobbiamo considerare. Secondo una serie di miti, il mondo e la qualità dell'umanità sono in declino, diventando sempre meno spirituali e sempre più materialisti ed egocentrici. Secondo l'altra serie di miti, c'è un progresso naturale e forse inarrestabile. Il primo gruppo di miti tende a concentrarsi sulla società (la società è in declino), mentre i miti del progresso tendono a concentrarsi sull'individuo (l'individuo ha più libertà e può essere più creativo).
Uno dei primi miti sul progresso dell'umanità fu creato da Gioacchino della Fiori (1135-1202 circa). Gioacchino fu il fondatore di un proprio ordine monastico e uno dei più importanti teorici storici e apocalittici del Medioevo. Egli concepì tre grandi ere: l'era del Padre, l'era del Figlio e l'era dello Spirito Santo. Di conseguenza, nella prima di queste ere, le persone vivevano sotto la Legge e servivano Dio. Durante la seconda era, le persone vivevano sotto il Vangelo, anche se Cristo aveva dato la libertà all'umanità. Solo nell'ultima era, tuttavia, ci sarebbe stata la piena libertà. Uno schema simile è stato elaborato dall'occultista inglese Aleister Crowley (1875-1947), che concepiva il tempo come divisibile in Eoni di Iside, Osiride e Horus, con l'umanità che avrebbe finalmente acquisito la libertà e l'individualità nell'ultimo.
Al contrario, secondo la tradizione indù, ci sono quattro grandi ere o Yuga, che iniziano con il Satya Yuga (l'era della verità) e terminano con il Kali Yuga (l'era oscura). Allo stesso modo, l'antico poeta greco Esiodo sosteneva che gli dei avessero creato diverse "razze". La prima di queste era una razza di persone dorate. Vivevano in armonia con la natura e tra loro e godevano di una vita lunga e sana. Poi vennero una razza d'argento e una di bronzo e infine una di ferro. Anche la mitologia norrena narra che agli albori della terra gli dei possedevano oro in abbondanza (a simboleggiare un'età dell'oro). Alla fine, però, ci fu una guerra cosmica tra gli dei e i giganti. In tutti e tre i miti, l'era finale era - o sarà - descritta in termini quasi identici: i fratelli combatteranno tra loro, i genitori saranno disonorati, gli uomini e le donne si uniranno solo per desiderio sessuale, gli uomini potenti e corrotti saranno rispettati.
Sebbene non fosse interessato a questi miti, Ibn Khaldun sosteneva che un tale declino fosse del tutto reale. Nato a Tunisi nel 1332, Ibn Khaldun è spesso considerato il padre della sociologia. Durante la sua vita, fu testimone dell'ascesa e della caduta di dinastie in tutto il Nord Africa. Riflettendo su questo, affermò che ogni dinastia attraversa tre fasi. Nella prima fase, una banda di guerrieri piomba su un regno, lo sconfigge e lo conquista. In questa prima fase, i guerrieri, sebbene vittoriosi, rimangono fedeli ai valori del deserto. Non si curano del lusso e dormono per terra. Nella fase successiva, il popolo gode del lusso del regno, ma spera di tornare a uno stile di vita più rude, che ammira. Nella fase finale, il popolo ama il lusso, è debole e cerca protezione dal sovrano. Incapace di difendersi, una nuova banda di guerrieri piomba su di esso e lo conquista, ricominciando il ciclo.
Potremmo trovare un'immagine della nostra civiltà da qualche parte nello schema di Ibn Khaldun. Ovunque ci collochiamo al suo interno, l'implicazione è sicuramente che né il lusso e la sicurezza né il guerriero da soli sono sufficienti per creare o sostenere una civiltà. Al contrario, come forse in ogni società premoderna di successo, è necessario un rapporto armonioso tra l'artigiano, il guerriero e il mago. Se la civiltà che ci circonda non è in grado di farlo, noi, individualmente, possiamo e dobbiamo incarnare e unificare questi archetipi nella nostra vita.
I seguenti utenti hanno detto grazie : gpeppe.abruzzese, prati
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Tempo creazione pagina: 0.558 secondi